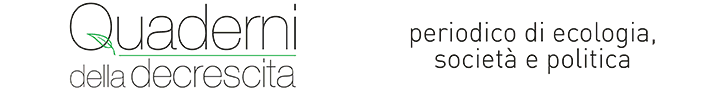Pubblichiamo una sintesi della monografia “Decrescita, nuovo nome della pace”, a cura di Marinella Correggia (autrice dell’articolo “Coltivare la pace”). Tutti i testi sono disponibili nei “Quaderni della decrescita” (www.quadernidelladecrescita.it).
L’ultimo dei Quaderni della Decrescita ha una monografia dedicata alla pace, e alle guerre. E il 24 maggio (anniversario dell’entrata dell’Italia nel primo Grande macello mondiale), la monografia ha ispirato l’assemblea “L’intelligenza del disertore”, che oltre a presentare il numero ha proposto collegamenti con chi dice No (obiettori di coscienza) sul fronte russo-ucraino e israelo-palestinese ed è stata impreziosita dalle canzoni in diretta dell’artista Valentino Santagati, al quale si deve l’espressione suindicata, conversione pacifista di quella “intelligenza con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano” che è punita con dieci anni di carcere a norma dell’articolo 243 del codice penale.
Pace, Isaia oggi, spade convertite in vomeri (e perfino l’agnello accanto al leone)…Ma nel mondo iper-tecnologico del XXI secolo e con un’industria degli armamenti in crescita – come le spese militari, non continua a essere pura utopia un disegno di pace, magari kantianamente perpetua? La domanda tira, insieme alle guerre; Leonardo riconverte rapidamente alla rovescia, dal civile al militare e perfino la legge 185/1990 che regolamenta fra l’altro l’export di armi, appare sotto attacco. E’ anche evidente che le azioni per la pace da parte di lavoratori e cittadini non riescono – e sono riuscite pochissime volte – a contrastare l’economia di guerra. Anzi, con la trasformazione post-fordista della produzione di armamenti, la resistenza dei lavoratori è ancora più difficile. Vale anche per la conversione delle basi militari, nazionali o straniere, malgrado alcuni successi, elencati in particolare dalla rete internazionale World Beyond War, come il caso di Vieques, Puerto Rico. Chiusa dopo 60 anni di soprusi e inquinamento, al quale la popolazione oppose una resistenza senza violenza, basata sulla disobbedienza civile.
A volo di colomba, ecco i brevi saggi e gli articoli (18 in tutto) apparsi sull’ultimo dei Quaderni.
Il messaggio centrale è che per uscire dalla crisi in atto dobbiamo uscire dall’economia di crescita, favorendo un disarmo ecologico in grado di ripristinare equilibri ambientali sostenibili e un clima vivibile, oltre a scongiurare il pericolo di guerre. Se l’obiettivo della crescita continua non è né praticabile né auspicabile, e comunque porta ad un’economia della scarsità e al rischio di guerra, che non può certo rendere felici, possiamo allora ipotizzare una decrescita che garantisca. In altre parole dobbiamo produrre meno merci, realmente necessarie, durevoli ed aggiustabili, consumando meno risorse e garantendo più occupazione, non per vivere peggio, ma tutti decisamente meglio
Nei suoi due interventi, “Guerra giustizia e disarmo ecologico”, e “Segnavia”, Marco Deriu spiega che è sempre più chiaro che oggi contrastare la dipendenza della guerra significa abbandonare il paradigma dell’accumulazione illimitata e depotenziare, rallentare, decrescere. Non lo sviluppo sostenibile e tantomeno la crescita verde, ma piuttosto la decrescita è oggi il vero nome della pace. Il carattere sempre più sistemico che ha assunto la violenza nel contesto attuale può essere rilevato anche considerando come l’economia capitalistica si è sviluppata in maniera sempre più integrata con l’industria bellica. Questa integrazione sempre più stretta può essere valutata in maniera ancora più precisa osservando tre dimensioni fondamentali: – la connessione tra consumo di risorse e conflitti per le risorse; – il ruolo della finanza e delle banche nella produzione e nel commercio di armi; – la simbiosi tra industria militare e industria civile.
Da questo punto di vista la logica della sicurezza basata sulle armi è un esempio paradigmatico dell’illusione della crescita. Ogni paese si arma e investe sulla difesa per aumentare la propria sicurezza, ma poiché la vulnerabilità è una questione relazionale, ogni investimento e innovazione in questo campo non porta ad una maggiore sicurezza ma semplicemente sposta in avanti l’asticella del confronto e della minaccia con altri soggetti, producendo un’escalation potenzialmente autodistruttiva e marginalizzando la ricerca di altre risorse e strumenti diplomatici e relazionali. Dobbiamo cominciare a invertire questa logica.
Importante: Marco Deriu – citando lo storico americano Gabriel Kolko – argomenta sull’impossibilità del controllo razionale e pianificato della violenza e della guerra. Tutto può sempre sfuggire e questo rende ancora più folle il gioco al massacro.
Un po’ di dati. Il clima è sempre più bellico. Secondo l’Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) nel 2023 si è verificato il 12% in più di conflitti rispetto al 2022 e un aumento di oltre il 40% rispetto al 2020. Tra questi i conflitti con i livelli più alti di violenza sono almeno una cinquantina. Attualmente circa una persona su sei vive in un’area attivamente in conflitto. Ci sono alcune zone del pianeta dove intere generazioni non hanno mai conosciuto la pace. Dove da 20, 30, 50, 70 anni i bambini e le bambine nascono e crescono nella guerra, in mezzo a violenza, scontri, bombe, paura, corpi straziati, lutti, dolore, rabbia, impotenza, risentimento. Paesi come il Congo (28), l’Iraq (34), la Somalia (38), l’Afghanistan (45), il Sudan (69), Myanmar (76), la Palestina (76), per ricordare alcuni dei casi più cronici
Eppure nei paesi occidentali – l’Italia inclusa – domina nella classe politica e nei centri di potere mediatico e informativo l’idea che la guerra sia un’opzione realistica. Questo nonostante gli interventi in paesi come l’Iraq, l’Afghanistan, la Somalia, la Libia, la Siria, il Mali si siano rivelati inconcludenti o controproducenti
Da dove ripartire?, si chiede Marco Deriu. Dai limiti che hanno caratterizzato negli ultimi decenni il movimento pacifista, nel nostro paese innanzitutto, e poi a livello internazionale; dallo spartiacque Iraq 2003, il 15 febbraio, 110 milioni nelle piazze del mondo, …tutto inutile. Crescita del senso di impotenza. Le pratiche politiche del movimento pacifista, marce, manifestazioni, sono importanti ma possono non essere sufficienti. È ovvio che il movimento pacifista ha nel proprio zaino tanti altri strumenti e modalità di intervento – dalle missioni e carovane per la pace, ai progetti sui territori attraversati dalle guerre, dalla ricerca scientifica sulla pace e sulle guerre al lavoro di educazione alla pace nelle scuole e nelle università, dall’obiezione di coscienza ai corridoi di sostegno ai disertori e ai profughi di guerra, dalle campagne contro le armi a quella contro le banche armate, dalle forme di disobbedienza civile nonviolenta alle proposte di difesa popolare nonviolenta ecc. Senza rinnegare nulla, non possiamo tuttavia evitare di domandarci con coraggio se oggi è necessario provare ad aggiornare, rinnovare e ampliare questo patrimonio e a immaginare pratiche nonviolente più capaci di praticare il conflitto sociale e politico, anche con le stesse istituzioni. Occorre trovare nuovi modi per portare alla luce i conflitti, per disvelare l’ingiustizia, per coinvolgere l’opinione pubblica e per spingere i governi a desistere. Occorre un pacifismo intersezionale, ragionare sula violenza strutturale. Abbiamo bisogno di elaborare in maniera più profonda la connessione tra pace e giustizia sia sul piano sociale che ambientale. Occorre ampliare e approfondire il lavoro di documentazione, di educazione (a partire dalle scuole), di ricerca scientifica (a partire dalle università), di giornalismo scientifico per contestare nel merito la retorica bellica, per far comprendere il reale impatto e l’eredità delle guerre sulla popolazione.
Gianni Tamino, dal canto suo, argomenta su “Crescita insostenibile, distruzione dell’ambiente, scarsità e guerre”. La crisi bellica è solo una delle tante facce della crisi generale causata da un sistema produttivo lineare, fondato su un paradigma meccanicista e riduzionista che non tiene conto dei limiti imposti dalle caratteristiche del nostro Pianeta. Un sistema produttivo che ritiene possibile una continua crescita delle produzioni e dei consumi non è sostenibile e provoca gravi conseguenze ambientali e sanitarie: inquinamento, perdita di biodiversità, cambiamenti climatici, epidemie e guerre.
Globalizzazione, carestie, epidemie e guerre. Le crisi ambientali e i cambiamenti climatici aumentano anche la probabilità di conflitti tra gli Stati, per il controllo della terra, per l’uso delle risorse, per l’acqua, ecc. Spesso queste guerre sono innescate e favorite da stati esterni a quelli belligeranti, interessati alle loro risorse naturali o agricole.
Oggi, comunque, la carestia non va intesa solo come scarsità di cibo, ma come carenza di tutte le materie prime necessarie alla società dei consumi (fonti fossili, metalli rari, litio, terre rare, ecc.). Questa è la principale causa delle moderne guerre.
Antonella Litta “Cambiamento climatico e inquinamento ambientale: le responsabilità delle guerre e del settore degli armamenti”; Pino Ippolito Arminio, “Guerra all’habitat. Le emissioni climalteranti delle attività belliche” e Silvana Galassi, “Danni di guerra: il debito ambientale provocato dai conflitti armati”, si soffermano sull’impatto ambientale dei conflitti e della loro preparazione. Finora la gravità dei conflitti armati è stata valutata soprattutto in base al numero delle persone che perdono vita o salute e delle distruzioni materiali, ma le conseguenze ecologiche delle guerre possono alterare le condizioni ambientali in modo tale da rappresentare un pericolo anche per le generazioni future in aree molto più estese di quelle belligeranti.
Nel cambiamento climatico e nell’inquinamento ambientale, le responsabilità delle guerre e del settore degli armamenti sono ormai acclarate, numerosi rapporti (citati nelle note) le sottolineano. Con i loro irrimediabili effetti.
Nel XXI secolo, le guerre per l’accaparramento delle risorse, divenute più “scarse” anche a causa dei cambiamenti climatici, si combattono prevalentemente attraverso il land and water grabbing, l’estrattivismo e le speculazioni commerciali e finanziarie, modalità che scandalizzano l’opinione pubblica molto meno delle guerre combattute con le armi. Alle guerre combattute con le armi si deve aggiungere anche la guerra mondiale dichiarata al clima che sta producendo i danni maggiori proprio nei paesi meno responsabili di averla provocata. Il debito ambientale provocato dalle guerre continua a essere ignorato, come in passato furono ignorati i debiti che si andavano accumulando in seguito alla rivoluzione industriale e alla cosiddetta “rivoluzione verde”. Gli autori si soffermano sulle conseguenze ambientali della guerra in Ucraina e in Palestina.
Solo un consenso globale sulla necessità di smettere di fabbricare armi e di emettere gas climalteranti potrebbe garantire un allentamento dei conflitti, in cui sono coinvolti schieramenti molto più ampi di quelli direttamente belligeranti.
La competizione per le risorse idriche è una delle cause scatenanti di conflitti, oppure un’arma di difesa e di offesa durante il conflitto armato tra Russia e Ucraina. Una pubblicazione uscita sulla rivista scientifica Earth’s Future, che riporta i risultati di ricercatori ucraini e statunitensi tratta proprio questo aspetto della guerra. E il rapporto 2023 del Pacific Institute ha contato 1623 conflitti causati dalla competizione per l’acqua nel corso della storia umana, di cui 228 nel 2022, con un aumento dell’87% rispetto al 2021.
Le spese militari e i sussidi per i combustibili fossili, con l’aggiunta di alcune imposte ambientali, se dirottate a favore dell’ambiente, sarebbero «più che sufficienti a finanziare la mitigazione, l’adattamento e il fondo perdite e danni», afferma il rapporto Climate Collateral (2022) sul rapporto fra spese militari globali ed emergenze di origine climatica.
Dall’Ucraina, Alberto Capannini dell’Operazione Colomba (Associazione Papa Giovanni XXIII), scrive: “Mi pare evidente che una guerra non può essere lasciata a chi la fa e la subisce, a meno di non voler accettare che vinca non chi ha più ragione, ma chi è più armato e più disposto ad esercitare senza misura la violenza sul nemico. (…) Le Nazioni Unite, la Comunità Europea, sono state create dopo guerre mondiali perché non si ripetessero più altre guerre, ma oggettivamente non ci sono più, non impediscono la guerra, non sanno pensare alternative, non possono o vogliono prevenire lo scoppio del conflitto armato. Sono lontanissime dalla vita di chi soffre, una distanza mortale…”. E che fare? Di certo “lavorare insieme agli unici esperti in materia, quelli che sono dalla parte sbagliata delle bombe, dei proiettili o dei droni”. E “accorciare la distanza tra quel che si dice e quel che si fa; tra la nostra sicurezza garantita e il suo futuro vuoto di tutto”.
Alfonso Navarra contesta i valori presunti virili dell’eroismo bellico, visti come suprema manifestazione del sacro dovere di difendere la Patria e il diritto internazionale. In particolare la guerra in Ucraina sembra averli riportati in auge. La nonviolenza efficace è il cammino alternativo che dobbiamo imparare a percorrere. Il tentativo è quello di una difesa basata sulla forza dell’unione popolare che sappia scompaginare e spezzare le catene di comando del potere militarista invasore.
Se in certi contesti la legittima difesa armata si giustifica, la guerra di aggressione non è mai giusta. Quali sono i motivi per cui la “giustizia” oggi, ammesso che mai lo sia stata in passato, non ha nulla più a che fare con la guerra? Ecco i due principali. Primo: qualsiasi impiego di armi oggi, stante il loro sviluppo tecnologico e le loro modalità di impiego, danneggia più gli innocenti civili estranei che gli implicati direttamente nel conflitto, e danneggia la Terra, cioè il corpo vivente di tutti gli umani. Secondo: non possiamo non sapere, oggi, che esiste l’alternativa efficace dei metodi di resistenza nonviolenta.
Una figura di riferimento è Johan Galtung, da poco scomparso, grande teorico della prevenzione e soluzione nonviolenta dei conflitti. Da studiare il suo “transarmo”, dall’organizzazione militare alla modalità di resistenza popolare nonviolenta, passaggio progressivo dalla difesa offensiva alla difesa difensiva. Si pone fra il riarmo e il disarmo, in opposizione al primo, e transizione verso il secondo.
Un concetto da non dimenticare è il “Triangolo della violenza”, comprendente tre tipi di violenza interdipendenti: la violenza diretta, la violenza strutturale (ingiustizia, segregazione, emarginazione) e la violenza culturale o simbolica, impregnata di pregiudizi, sessismo, razzismo. Il “Triangolo della violenza” è utile per fondare la distinzione tra “pace negativa” e “pace positiva”,
L’obbedienza rimane essenzialmente un fatto di volontà, si può sempre scegliere, come persone e gruppi di persone, di obbedire o di disobbedire.
Alberto Leiss si sofferma sugli attuali sacrifici umani in guerra: “ Decine di migliaia di giovani maschi russi e ucraini si uccidono sul fronte aperto “nel cuore dell’Europa. Mentre in Palestina alla violenza di Hamas sulle donne e gli uomini nelle zone di confine, ha fatto seguito una guerra devastante condotta sulla popolazione di Gaza”. Occorre interrogare la radice sessuata e maschile della pratica bellica. Per liberarsi dei condizionamenti del patriarcato occorre farla finita con le suggestioni del “coraggio” e del senso di sé legati al rischio della vita nella competizione con il “nemico” di turno.
L’autore individua anche le pecche di certo “pacifismo istituzionale”, un pacifismo che non elimina l’uso della forza ma lo limita: non costituisce certo un’alternativa alla violenza, ma soltanto a una sua riduzione…”. Il pacifismo istituzionale riposa sul meccanismo che possa esistere un “terzo”, una istanza superiore alle parti in causa, nel caso della guerra gli Stati. Su questa base ci fu chi finì per giustificare non solo la prima guerra nel Golfo dopo l’invasione del Kuwait da parte dell’Irak, ma anche le successive guerre “umanitarie”. E oggi stiamo constatando che il ruolo “terzo” svolto dalle Nazioni unite è ben distante dall’essere efficace. Dunque, “forse bisognerebbe chiedersi se la capacità egemonica delle democrazie occidentali che oggi gridano ‘alle armi!’ contro Putin (pensando soprattutto al potere di Pechino), non stia naufragando proprio per il ricorso costante alla guerra anche nei decenni seguiti al crollo del muro di Berlino e alla fine della cosiddetta guerra fredda”.
Monica Lanfranco sottolinea il ruolo delle “Donne che disarmano”: “Le femministe hanno rimesso in discussione anche la logica della violenza rivoluzionaria e l’immagine del condottiero armato che per abbattere il sistema oppressivo giustifica l’uso della violenza. Le donne hanno invece promosso un’ampia varietà di pratiche politiche nonviolente – dalle donne in nero, alle attiviste indiane in difesa dei semi e delle foreste, alle manifestazioni in Inghilterra contro la costruzione dei caccia Hawk 955 – capaci di produrre un conflitto generativo e di tessere reti di collaborazione sociale, culturale e politica. (…) È il femminismo il vero umanesimo, e il pensiero politico che unifica tutte le grandi utopie: quella socialista, quella pacifista, quella nonviolenta, quella anticapitalista (Nawal al-Sa’dawi)
Occorre resistere al fascino della violenza rivoluzionaria: «Non si può smantellare la casa del padrone con gli attrezzi del padrone» è una frase della femminista e poeta afroamericana Audre Lorde.
Rocco Altieri percorre la raccolta, curata da Erasmo da Rotterdam, di proverbi e detti provenienti dalla cultura classica (adagia) che rappresentavano la forza nonviolenta della parola di contrasto alla brutalità e alla follia della guerra.
Davvero, la pace è questione troppo gravosa e importante per lasciarla alla decisione di prìncipi e pontefici. Bisogna che il popolo si riprenda il potere su questioni di vitale interesse come la guerra e la pace.