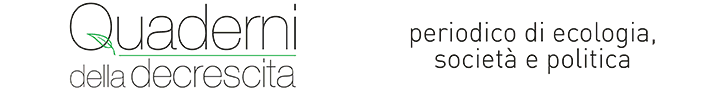Senza relazione non c’è verità
Non ci sono dubbi che il sistema economico sta affrontando una crisi globale di portata storica come non accadeva dal 1929. Le sofferenze, in particolare per i più deboli, non hanno precedenti negli ultimi settanta anni. Per quanto ormai nessuno neghi la dimensione globale della crisi, gli economisti negano decisamente che ci troviamo di fronte ad una crisi di sistema. I due concetti infatti, per quanto vengano sovente confusi, indicano due realtà ben diverse: mentre la prima fa rifermento alla scala del processo, ma rimane limitata essenzialmente alla sfera economica, la seconda coinvolge l’intero sistema ecologico-umano considerato nella sua interezza (Human Ecological System, HES, Raskin, 2008). Questo comprende, oltre alla dimensione economica, almeno altre tre dimensioni: quella biofisica, relativa cioè alle interazioni con l’ambiente naturale, quella sociale (di qui le relazioni economiche sono solo una parte) e infine una dimensione culturale (rappresentazioni, valori). In altre parole per crisi sistemica si deve intendere una sorta di crisi di civiltà, la cui evoluzione può portare al collasso, ossia alla perdita di complessità, in tempi più o meno lunghi, di un certo tipo di organizzazione sociale, e la sua sostituzione con qualcosa d’altro (Tainter, 1988).
Seguendo Gregory Bateson (1972), una lettura “a grana grossa” dei processi che possono condurre verso una crisi di questa natura ci deve portare a ricercare, all’interno del HES, innanzitutto quei processi di feedback positivo che possono portare il sistema lungo una spirale autoaccrescitiva. Tali processi, infatti, quando superano certe soglie, producono perturbazioni in altri sistemi che, se non adeguatamente compensati (feedback negativo) mettono a rischio le capacità di autoriproduzione del sistema stesso. La nostra analisi si concentrerà dunque prioritariamente sul tentativo di enucleare alcuni di questi processi “fondamentali” che caratterizzano l’evoluzione di tempo lungo del HES, a scala globale, oltre che sulle relazioni tra questi.
Crescita, accumulazione e innovazione come processo auto-accrescitivo
Il fatto che una parte dei profitti realizzati dalle imprese sia reinvestita andando ad accrescere la dotazione di capitale, la quale, attraverso l’innovazione tecnologica, diviene la base per realizzare nuovi profitti, rappresenta il tratto fondamentale dell’economia moderna che possiamo in questo senso, definire “capitalista”. Questo processo spiega l’inarrestabile crescita economica che ha caratterizzato, sin dalla rivoluzione industriale, queste economie e che era invece sconosciuta a tutte le forme di organizzazione economica e sociale precedenti. I dati riportati da Angus Maddison illustrano bene questo fatto:
L’economia Europea è cresciuta di 47 volte dall’inizio del processo di industrializzazione (1820) ad oggi (2001), l’America del Nord addirittura 678 volte in termini reali, l’economia globale 53 volte. La popolazione è crescita di 2,9 volte in Europa nello stesso periodo (da 133 a 392 milioni di abitanti), 30,9 volte nel Nord America (da 11 a 340 milioni) e 6,1 volte a livello globale (da 1 a 6,1 miliardi). Nonostante il forte incremento della popolazione, i redditi pro capite sono cresciuti dal 1820 ad oggi ad una media del 1.2 l’anno, 24 volte più velocemente rispetto alle stime relative al periodo 1000-1820 (Maddison, 2005).
Se poniamo i dati relativi alla crescita dell’economia nel lungo periodo su un piano cartesiano possiamo notare chiaramente l’andamento di tipo esponenziale della curva per il periodo successivo a quella che Polanyi ha giustamente definito la “grande trasformazione”.
COMPARATIVE LEVELS OF GDP PER CAPITA: CHINA AND WEST EUROPE, 400–2001 (in 1990 international dollars)

Già gli economisti classici, Adam Smith e Marx in particolare, avevano inteso perfettamente che questo processo circolare e ricorsivo era il tratto fondamentale del sistema economico capitalista. Tuttavia, la controriforma neoclassica, mentre ha speso fiumi di parole per celebrare la (presunta) natura autoregolativa dei mercati, ha propugnato una visione di equilibrio economico generale, astorica, in cui nulla viene detto per sottolineare la natura autoaccrescitiva del processo di crescita/accumulazione/innovazione. La crescita, ovviamente non può essere negata ma, nei modelli neoclassici (alla Solow), viene ricondotta essenzialmente agli incrementi di produttività, cioè al progresso tecnologico, considerato esogeno. E’ chiaro invece che, particolarmente in un contesto competitivo, crescita, accumulazione e innovazione fanno parte del medesimo processo autoaccrescitivo, in cui non solo il progresso tecnologico sostiene la crescita, ma la crescita diviene la fonte per successive innovazioni, in un processo circolare e, appunto, autoespansivo.
Questo processo, sia chiaro, non comporta un mero incremento quantitativo, al contrario alla crescita dimensionale si accompagna una trasformazione delle strutture (principio di emergenza).
Il processo di crescita ha comportato anche una profonda trasformazione delle strutture produttive, ossia delle imprese. Questo processo ha raggiunto una sua maturità già agli inizi del ‘900, quando l’economia americana, prima fra tutte, ha assunto la forma di quel “capitalismo monopolistico” ben descritto da Baran e Sweezy (1968). Avvantaggiandosi delle economie di scala connesse alla produzione di massa di stampo fordista, le imprese capaci di realizzare i maggiori profitti hanno assorbito quelle più deboli, procedendo verso la concentrazione della produzione in poche grandi entità.
Ciò che importante sottolineare è come la crescita dimensionale comporti una inevitabile trasformazione della struttura (principio di emergenza), con conseguenze di non poco conto sugli equilibri/disequilibri del sistema. Pur nella straordinaria verità delle forme nei diversi contesti storici, geografici e politici, la capacita dimostrata da queste “megamacchine” di mantenere ed accrescere, attraverso il controllo monopolistico di qualche risorsa, o semplicemente in virtù delle proprie dimensioni, la posizione di forza acquisita, resterà un tratto caratterizzante del processo di sviluppo capitalistico. Questo processo porterà successivamente il mondo produttivo a strutturarsi secondo le forme tipiche della grande impresa multinazionale (Amin, 2002).
Un’analisi sistemica non dovrebbe mai trascurare, inoltre, di analizzare a fianco dei flussi, l’andamento degli stocks (o strutture) implicati nel processo. Occorrerà dunque tenere in considerazione, ad esempio, per quanto attiene la dimensione economica, oltre ai redditi, l’andamento della ricchezza. Essa come vedremo può essere altrettanto rilevante nel condizionare il comportamento degli agenti.
In conclusione, per quanto l’analisi sistemica sia in grado di evidenziare una molteplicità di spirali autoaccrescitive di questo genere, tuttavia il processo di crescita ed accumulazione del capitale assume, nella nostra prospettiva, un ruolo centrale nella dinamica del sistema mondo, e questo sia per la sua innegabile forza e pervasività, sia perché, come vedremo, gli altri più significativi processi autodistruttivi – dalla spirale della crisi ecologica a quella della povertà/esclusione – risultano come conseguenze della prima.
La spirale della crisi ecologica e l’ecologismo dei poveri
La teoria bioeconomica di Georgescu-Roegen (1971, 2003) rappresenta un punto di partenza imprescindibile per un’analisi critica dell’ortodossia economica, in particolare per quanto attiene il tema dei limiti ecologici alla crescita (Bonaiuti, 2001). Questi limiti sono, com’è noto, dovuti alla natura entropica del processo economico: secondo la legge di entropia ogni attività produttiva comporta l’irreversibile degradazione di quantità crescenti di energia e, sotto certe condizioni, anche di materia. Essendo la biosfera un sistema chiuso (scambia energia, ma non materia con l’ambiente) ne discendono due importanti conclusioni per l’economia: la prima è che l’obiettivo fondamentale del processo economico – la crescita illimitata della produzione e dei redditi – essendo basato sull’impiego di risorse energetiche e materiali non rinnovabili, risulta in contraddizione con le leggi fondamentali della termodinamica. Esso pertanto, va abbandonato o comunque radicalmente rivisto.
L’evidenza empirica accumulatasi negli ultimi trent’anni è del resto, a questo proposito, robusta e concorde: basta ricordare che l’impronta ecologica degli USA, ossia l’area degli ecosistemi terrestri ed acquatici richiesta per produrre le risorse consumate dalla popolazione americana, e per assimilarne i rifiuti, è circa 5 volte superiore alla disponibilità media globale. I valori dei paesi europei sono per ora circa due-tre volte superiori alla disponibilità media e la Cina ha un’impronta ecologica pro-capite oltre sei volte inferiore a quella americana (Chambers, C. Simmons, M. Wackernagel, 2000).
Non stupisce che un processo di crescita accelerata come quello descritto, debba prima o poi scontrarsi con i limiti biofisici del pianeta. Le simulazioni condotte già a partire dagli anni Settanta dagli studiosi del MIT, presentavano, per le fondamentali variabili economico ecologiche (disponibilità di risorse, popolazione, speranza di vita, produzione industriale, etc.): dapprima incrementi decrescenti a cui seguiva una vera e propria decrescita dei valori assoluti, secondo il caratteristico andamento “a campana”. Quello che ci interessa sottolineare qui, non è certamente formulare una previsione sulle possibili date del picco delle diverse variabili, quanto evidenziare il tipo di andamento che possiamo attenderci per le variabili fondamentali del sistema A meno della comparsa di tecnologie “prometeiche” esso presenterà il classico andamento a campana: prima crescente e poi decrescente. Diciamo per inciso che le simulazioni più recenti rielaborate dal gruppo del MIT, confermano, nello scenario base, picchi per la disponibilità di cibo ed altre variabili chiave, dell’ordine di 10-20 anni e cioè tempi estremamente ravvicinati se si considera l’”inerzia,” o più propriamente, i ritardi feedback, che caratterizzano i sistemi bio-economici (Meadows D. e D. Randes J., 2006). Certo agli indicatori aggregati, come l’impronta ecologica, vanno senz’altro affiancati altri indici più specifici, come i flussi di materia/energia, l’appropriazione umana della produzione primaria netta (HANPP) tuttavia, per chi voglia leggerli senza pregiudizi, già i dati che abbiamo richiamato manifestano apertamente come il sistema produttivo globale sia, già oggi, insostenibile per la biosfera.
Ma vi è una seconda tipologia di relazioni che sorgono nell’interfaccia tra economia, ecologia e società: la crescita continua della produzione e dei consumi comporta un incremento dei flussi di materia/energia provenienti, solitamente, dai paesi più poveri, generando conflitti sociali nei territori dove tali risorse vengono sfruttate. Questo “ecologismo dei poveri,” analizzato in particolare dalla scuola di Joan Martinez-Alier, rappresenta un processo importante, sia in quanto presenta significativi impatti sulla sfera sociale e sulla cultura delle popolazioni locali, sia in quanto i prezzi di molte risorse essenziali per il sistema produttivo mondiale, sono legati agli esiti di questi conflitti (Martinez-Alier, 2002). Come vedremo l’aumento dei costi delle risorse può giocare un ruolo fondamentale nel condizionare gli scenari di lungo periodo.
Limiti sociali allo sviluppo
L’analisi delle conseguenze della crescita economica sui sistemi sociali (quella che potremmo definire sostenibilità sociale) è certamente più complessa e controversa di quella relativa agli ecosistemi. Occorre riconoscere che la nostra comprensione della dinamica dei sistemi sociali è ancora estremamente limitata. Tuttavia, se non intendiamo rinunciare alla possibilità di raffigurarci possibili, per quanto incerti, scenari di in/sostenibilità futuri, le domande che sorgono in questo ambito risultano, per molti versi, imprescindibili.
Alla metà degli anni 70 Fred Hirsch, in un testo innovativo e straordinariamente in anticipo sui tempi, pose chiaramente la questione: esistono – al di la dei limiti ecologici (che egli peraltro considerava “incerti e lontani nel tempo”) dei limiti sociali alla crescita (Hirsch, 1976). Vediamo di cosa si tratta. Per cominciare Hirsch intuisce che la struttura delle preferenze degli individui subisce, mano a mano che aumenta la loro disponibilità economica, delle trasformazioni di tipo qualitativo. Questo è estremamente interessante dal nostro punto di vista poiché prefigura l’emergere di nuovi comportamenti legati alla scala del processo. Infatti l’osservazione del comportamento dei soggetti economici mostra come al crescere della scala dei consumi, una parte crescente della spesa delle famiglie si sposta dal consumo di beni “fondamentali” (ciò che è necessario per vivere, nutrirsi, coprirsi, ecc.) al consumo di beni “posizionali”. Quello che caratterizza un bene posizionale “puro” è il fatto che l’utilità che esso procura non è legata al suo “valore d’uso” (come nel caso del cibo), ma alla sua scarsità relativa. In altre parole ciò che conta, per i beni posizionali, è la differenza tra ciò che possiede ciascuno e ciò che possiedono gli altri. Tutti quei beni o servizi che vengono giustamente definiti “status simbol” (oggetti di prestigio, servizi più o meno esclusivi, ma anche ruoli professionali di leadership, ecc.) sono buoni esempi di beni posizionali. Anche l’istruzione, se la consideriamo unicamente come mezzo per ottenere un posto di lavoro ambito, è un possibile esempio di bene posizionale: mano a mano che aumenta il numero dei laureati, infatti, si riduce il beneficio del possedere una laurea. Naturalmente esistono una infinita varietà di sfumature e ciascun bene può presentare, a fianco di un certo valore d’uso (il del valore legato alla relazione con l’oggetto in sé, ad es. l’utilità del potersi spostare in auto) una più o meno ampia connotazione posizionale (l’utilità legata al fatto di possedere un’auto più prestigiosa e veloce degli altri).
Non deve sfuggirci la natura sistemica dell’interazione posizionale: mentre per i beni fondamentali possiamo trascurare l’interazione con altri individui – ad esempio il piacere che traiamo del bere un bicchiere d’acqua si può considerare ragionevolmente indipendente da ciò che fanno gli altri (i beni fondamentali sono dunque “beni privati”), il benessere associato al consumo di beni posizionali dipende dal comportamento degli altri soggetti. Anche in questo caso, al crescere della scala, emergono effetti generalmente discontinui. Superata una certa soglia, gli individui diventano “sensibili” alle interazioni con i propri “vicini”. Questo si osserva ad esempio nel caso di congestione fisica (traffico), ma anche quando, al crescere dei consumi, aumenta il numero di soggetti che condividono un certo spazio sociale (una strada, una spiaggia, un club): quando il numero di persone che posseggono quell’oggetto o frequentano quel luogo superano una certa soglia, il benessere individuale diminuisce rapidamente, con l’effetto che individui e gruppi si spostano verso altri oggetti/luoghi/simboli. In altre parole – per quanto sia ovviamente impossibile una misurazione rigorosa degli effetti sul benessere aggregato – risulta comunque chiaro che la competizione posizionale si presenta generalmente come un gioco a somma zero o addirittura a somma negativa.
Come al solito quello che interessa qui non è tanto l’analisi dei comportamenti micro, quanto piuttosto il riconoscimento, dietro la dinamica della competizione posizionale, di un effetto aggregato (o sistemico) con potenziali conseguenze auto accrescitive di lungo periodo. Come si è visto, seguendo le argomentazioni di Hirsch, la crescita economica aumenta la congestione/competizione posizionale. Tuttavia, è altrettanto vero che la competizione posizionale alimenta la crescita. E’ possibile qui scorgere una dinamica per molti versi complementare a quella messa in atto dalle imprese attraverso la continua innovazione: l’ambizione a possedere oggetti “unici” (anche quando prodotti in milioni di esemplari) inseguendo “l’ultimo modello,” o i dettami della moda, di cui gli esperti di marketing sono al tempo stesso interpreti e modellatori (attraverso il megafono mediatico) alimenta la produzione di continui nuovi oggetti/simboli rinforzando la crescita economica. Il circolo in questo modo si chiude e si autoalimenta, con l’importante aggravante che, a differenza di quanto accade per il consumo di beni fondamentali (o semplicemente di beni in quanto tali), la domanda di beni posizionali è, per sua natura, sostanzialmente illimitata.
A questo punto sorgono spontanee alcune domande di natura storico/antropologica che riguardano l’estensione, il radicamento, l’evoluzione dei consumi posizionali in ciascuna società, domande che richiederebbero inoltre una chiarificazione del legame che sussiste tra questo tipo di consumi (ma potremmo forse più propriamente parlare di stili di vita o di habitus) con le gerarchie sociali ed economiche. Domande che complessificano il quadro oltre i limiti che ci siamo imposti qui e che in buona parte attendono ulteriori ricerche. Possiamo tuttavia delineare un paio di passaggi sufficienti a trarre alcune prime conclusioni.
Il bisogno di distinzione sembra profondamente connaturato all’homo sapiens ed è presente nelle culture più diverse, anche le più semplici e arcaiche, e non va pertanto giudicato negativamente in quanto tale. Va dunque colta la specificità che caratterizza il consumo posizionale nelle società industriali contemporanee. Da tempi antichi il consumo posizionale è sempre stato connesso ad uno status sociale che trovava le propri radici per lo più al di fuori della sfera economica. Naturalmente le cose cambiano con l’avvento della società di mercato e del consumo di massa. Ancora una volta ritroviamo alla radice un problema sensibile alla scala. E’ chiaro che è solo dopo l’avvento dell’economia di mercato, ed in particolare con quella trasformazione strutturale nota come “consumismo” che una parte significativa dei consumi divengono consumi posizionali di massa.
E’ a questa scala che la relazione circolare tra crescita e aumento del consumo posizionale diviene insostenibile (in termini ecologici), in quanto non è immaginabile una rincorsa emulativa nei consumi posizionali estesa all’intera popolazione del pianeta. Come noto oggi circa l’ottanta per cento della popolazione si appropria solamente del 20% del consumo complessivo: in altre parole una parte assai significativa è rimasta sinora esclusa dalla competizione posizionale, ma sta bussando alle porte, desiderosa di entrare a far parte del gioco. Ne possiamo dunque concludere, a differenza di quanto sosteneva Hirsh, che non solo l’esistenza di limiti sociali allo sviluppo non sminuisce la rilevanza dei limiti ecologici, ma che, alla scala attuale, tra la crisi sociale e la crisi ecologica esiste una stretta e innegabile relazione.
L’ingresso di sempre nuovi giocatori nel ciclo della competizione posizionale, inoltre, da luogo ad un processo di frustrazione sistematica (e non occasionale) delle aspettative dei singoli, che si riflette in una perdita di benessere. Rimanere bloccati nel traffico per recarsi al lavoro, spendere un parte significativa del proprio denaro e del proprio tempo per comprare oggetti che si dimostrano presto sostanzialmente identici a tutti gli altri, studiare per molti anni per poi non riuscire a trovare lavoro, sono semplici esempi quotidiani di questa perdita di qualità della vita.
Tuttavia, le spese dei singoli agenti che abbiamo descritto vengono sommate negli indici della contabilità nazionale, che dunque mostrano un continuo aumento dei consumi e del Prodotto interno lordo. Non solo: la frustrazione subita, (affiancata da altre cause di malessere ecologico e sociale che vedremo) da luogo ad un ampia serie di spese di carattere difensivo, (es. spese per la sicurezza, assicurative, per la difesa della salute, ecc.) che pur non portando alcun miglioramento nel benessere, portano ad un ulteriore incremento del PIL.
Questo aiuta a comprendere come i processi di competizione posizionale siano un fattore importante di quel paradosso del benessere su cui si è concentrata, giustamente, l’attenzione di un numero crescente di economisti negli ultimi anni.[2] In sostanza quello che si è presentata agli occhi dei ricercatori è una situazione in cui a fronte di un aumento, anche massiccio, del reddito pro capite, il benessere soggettivo non aumenta o addirittura diminuisce. Più precisamente l’indice così calcolato è diminuito per gli USA da 2,4 a 2,2 nel periodo compreso tra il 1946 e il 1991 a fronte di un aumento del reddito pro capite del 250% nello stesso periodo. Risultati ancora più impressionanti riguardano il Giappone dove a fronte di incrementi del reddito pro capite del 600% (dal 1958 al 1991) le persone che si dichiarano “molto felici” è rimasto sostanzialmente invariato. Se consideriamo i dieci paesi più avanzati possiamo concludere che nessuno di questi presenta una correlazione positiva tra il reddito pro capite e l’indice di benessere soggettivo, mentre due di essi (USA e Belgio) presentano una correlazione significativamente negativa (Kenny, 1999; E. Diener e E. M. Suh, 1997).
Come è già stato notato, la teoria economica standard, e l’azione politica che a questa si ispira, non è in grado di cogliere questo paradosso. Tuttavia, sino a quando il processo economico era nella sua fase iniziale di sviluppo, in cui le interazioni posizionali risultavano complessivamente deboli (o altrimenti regolate) e il consumo era fondamentalmente consumo di beni privati, si poteva generalmente assumere che il comportamento autointeressato degli agenti (la smithiana mano invisibile) potesse condurre il sistema verso un maggiore “benessere sociale”, (quanto meno se siamo disposti ad ammettere che la produzione efficiente di beni privati coincida con il benessere).
Tuttavia, quando il sistema entra in quella che possiamo definire una “prima fase di maturità” in cui i bisogni fondamentali possono ritenersi soddisfatti e, in virtù della crescita economica e della popolazione, le interazioni tra i soggetti si fanno più intense, assumendo un prevalente carattere posizionale, un sistema di allocazione delle risorse che, come quello attuale, trascuri le proprietà emergenti a livello aggregato, non può che fallire nel perseguimento del benessere sociale.
Alcune conclusioni critiche a commento dell’analisi di Hirsh. Come abbiamo visto la competizione posizionale – a differenza dei “limiti ecologici” – non costituisce propriamente un “limite sociale alla crescita,” nel senso che questa non solo non impedisce la crescita stessa, quanto piuttosto ne alimenta la continua espansione (feedback positivo). Il processo, tuttavia, conduce, come abbiamo visto, ad una sorta di frustrazione generalizzata e dunque costituisce, più propriamente, un limite al “benessere sociale”. Indirettamente – questo è certo – la competizione posizionale, attraverso l’aumento dei consumi, spinge il sistema verso il limite ecologico. Il processo ha indubbiamente portata sistemica, anche poiché la competizione posizionale non si scatena solamente a scala individuale, come negli esempi riportati, ma tra gruppi, tra regioni e sopratutto fra stati.
La “corsa agli armamenti” rappresenta l’esempio più ovvio. Ma non si deve dimenticare quanto molti stati tuttora investano affinché le proprie economie siano competitive e raggiungano gli standard di vita occidentali (il caso della Cina è a questo proposito paradigmatico, ma si potrebbe estendere ad altri paesi). In generale se pensiamo a tutti gli sforzi economici e sociali, che – a varie scale – soggetti organizzati pongono in essere al fine di inseguire – o di difendere – posizioni di forza, di prestigio, o come si dice, di leadership, si comprende la portata delle dinamiche posizionali ed il loro ruolo determinante nella dialettica della modernità. Il re è nudo, ma sembra che nessuno voglia accorgersene: in altre parole occorre essere consapevoli della discontinuità che segna quest’ultimo passaggio di scala: mentre infatti l’emergere del consumo posizionale di massa negli anni sessanta da un parte sosteneva la crescita e dall’altra, proiettava l’ombra della futura crisi ecologica e sociale, la competizione posizionale planetaria, implicita nella logica della globalizzazione, rappresenta semplicemente una impossibilità rispetto alla quale non è ancora chiaro quali processi adattivi o di trasformazione radicale si vorranno tentare.
La spirale dell’esclusione e la critica dello sviluppo
In termini molto generali potremmo dire che, sino ad oggi, la questione della sostenibilità sociale è stata affrontata essenzialmente in termini di equità (Sachs, 2002, 2007). L’idea, ampiamente condivisa, è che, poiché i sistemi sociali sono sensibili alle differenze (di reddito, di status ecc), una maggiore diseguaglianza è considerata come un fattore generatore di conflitti ed instabilità sociale. Come è facile comprendere la domanda di fondo sottostante questo approccio alla sostenibilità è se la crescita e lo sviluppo siano da considerarsi, come sostiene la teoria neoclassica della convergenza, portatori di una più equa distribuzione della ricchezza tra i diversi paesi e aree geografiche o piuttosto il contrario.
Fino alla metà degli Settanta il consenso verso le politiche di sviluppo, anche come strumento per favorire una più equa redistribuzione, è stato pressoché unanime. Sono gli anni del boom economico, della produzione di massa e del patto keynesiano tra capitale e lavoro… Sul fronte internazionale, a partire dal famoso discorso sullo stato dell’Unione tenuto dal Presidente Truman nel 1949, lo sviluppo diviene la parola d’ordine con cui l’Occidente si presenta nei confronti dei paesi terzi (che non a caso divengono, da allora, “paesi in via di sviluppo”). È così che la politica egemonica dell’Occidente viene mascherata dietro un colossale programma di emancipazione universale: l’intero pianeta veniva chiamato a seguire l’Occidente lungo “magnifiche sorti e progressive” della crescita e dello sviluppo. (G. Rist, 1997)
Naturalmente non si vogliono negare qui i miglioramenti nelle condizioni materiali di vita che si sono avuti, quantomeno nei paesi occidentali, in questo periodo, e particolarmente nel ventennio 1955-75. Tuttavia, quantomeno a partire dagli anni Ottanta, è diventato sempre più evidente che, a dispetto delle pretese universaliste dell’Occidente, la ricetta dello sviluppo non era estensibile a tutti (S. Latouche,1993, 1997).
I dati di cui disponiamo a questo proposito parlano chiaro: il Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’intero continente africano è, ancora oggi, inferiore al 2% del PIL globale. È ormai evidente che l’Africa, e molte zone interne dell’Asia, restano al palo. In generale, a livello planetario, le differenze di reddito tra i più ricchi e i più poveri si allargano drammaticamente. Un solo dato per tutti: il reddito annuale dell’ 1% più ricco del pianeta supera la somma dei redditi annuali del 57% della popolazione più povera (oltre 3 Miliardi e cinquecento milioni di persone; UNDP, 1999, 2002).
Lo scenario globale è sempre più quello in cui ricchezza e benessere coesistono con un vasto panorama di esclusi dal banchetto della società di consumo. Quali che siano le cifre di cui ci si serva per drammatizzare questa realtà (2 miliardi e 737 milioni di persone che vivono con meno di due dollari al giorno o un bambino morto ogni 3 secondi) esse stanno a testimoniare che non solo l’Occidente non è stato in grado di estirpare la vergogna della miseria, ma che alla crescita e al miglioramento delle condizioni dei più ricchi non corrisponde, come pretendevano i teorici dello sviluppo, alcun “naturale” miglioramento delle condizioni dei più poveri. Inoltre il dramma dell’esclusione non riguarda solamente le aree più povere del pianeta, ma si affaccia all’interno degli stessi paesi ricchi: qui diversi sono i percorsi di disagio e di emarginazione, in ogni caso i così detti “nuovi poveri” si contano ormai in oltre 100 milioni tra Europa e Stati Uniti.
E’ possibile individuare una dinamica di fondo che renda conto di come e perché il grande sogno occidentale di offrire condizioni di vita materiale in continuo miglioramento per l’intera umanità sembra essersi infranto ?
Per quanto il quadro sia indubbiamente complesso e condizionato dalla diversità delle condizioni storiche e politiche di ciascun paese, per i critici dello sviluppo (I. Illich, F. Partant, S. Latouche) il principale responsabile della miseria e dell’esclusione va ricercato proprio laddove si pretendeva di trovare la soluzione, ossia nelle politiche di crescita e sviluppo. Questo apparente paradosso può essere tuttavia compreso nell’ambito di un approccio sistemico: il processo di crescita/accumulazione/innovazione segue, come abbiamo visto, una dinamica autocrescitiva. I maggiori investimenti che i paesi occidentali hanno realizzato a partire dagli albori del processo di industrializzazione, hanno generato un accelerato progresso tecnologico che ha dato luogo sia ad incrementi di produttività che a continue innovazioni. I forti profitti così realizzati sono stati reinvestiti alimentando ulteriori incrementi di produttività… Data la natura competitiva dei mercati internazionali è evidente che chi non è riuscito a restare al passo con l’innovazione ed il progresso tecnologico si è trovato di fronte – oltre alla distruzione delle culture e delle economie tradizionali – ad un gap tecnologico sempre più difficile da colmare. E’ ormai chiaro a tutti che, nei paesi più avanzati, la produttività ha raggiunto livelli tali che una minoranza è in grado di produrre tutto ciò di cui abbisognano le economie mondiali. Gli altri, i “naufraghi” dello sviluppo (intesi sia come individui che come interi stati nazione), sono incapaci di prendere parte a questo gioco poiché non sono sufficientemente efficienti, competitivi.
Non stupisce che, nel tempo, questo vantaggio competitivo sia andato “depositandosi in strutture istituzionali (militari, finanziarie, tecnologiche, mediatiche) che tendono a conservarne, e per quanto possibile, ampliarne il vantaggio posizionale conseguito. Se questa è la dinamica di fondo che ha segnato sino ad oggi la parabola dello sviluppo, non stupisce il trovarsi di fronte ad un’economia-mondo polarizzata, in cui i contrasti tra il centro e la periferia risultano sempre più marcati – sia su scala globale (S. Amin, 2002) che locale – e dove la crescita, anziché risolvere, alimenta il dramma della povertà e dell’esclusione (Latouche, 1993, 1997).
Va detto tuttavia che, a fianco di questa dinamica di fondo, operano anche processi processi di natura riequilibrativa, (o feedback negativo). Questi processi di “perticolazione” della ricchezza (trickle dawn effect), sono dovuti a varie ragioni: a livello nazionale sono legate alle dinamiche riequilibrative del welfare state, e a livello internazionale, agli investimenti esteri e ai processi di imitazione/ apprendimento della periferia. Essi possono spiegare come ricchezza e benessere materiale si diffondano verso una serie di paesi (come la Cina e l’India) dando luogo al sorgere di una nuova “classe media” globale. La presenza di questi effetti, tuttavia, non mette in discussione le conseguenze polarizzanti del processo di crescita/accumulazione/innovazione che costituisce per dimensioni e storia, il processo primario. Questo sarà ovviamente tanto più vero quanto la dinamica autorinforzante del processo di crescita venga lasciata libera di dispiegarsi, in assenza, cioè, di qualsivoglia intervento redistributivo da parti delle istituzioni sovranazionali. Come sappiamo questa è stata precisamente la politica sostenuta dal WTO, IMF, Banca Mondiale in questi ultimi venticinque anni di globalizzazione.
Crescita e dissoluzione dei legami sociali
Se il problema della insostenibilità sociale trova un suo primo fondamentale ancoraggio nella questione della povertà e dell’esclusione, è ormai chiaro nell’analisi socio-antropologica contemporanea che non è possibile limitarsi alla sola questione dello sfruttamento e alle dinamiche, pur importantissime, che abbiamo enucleato. Già Marx, nella sua illuminante descrizione del feticismo della merce, aveva perfettamente inteso che dietro allo scambio si nascondeva una particolare struttura di relazioni sociali: in altre parole lo scambio di mercato nasconde – oltre ai rapporti di forza – le specifiche condizioni sociali (il “come” e il “dove”) della produzione.
In continuità con questa lettura – ma arricchita delle seminali acquisizioni dell’antropologia di inizio secolo sulle società “primitive” (Malinowsky) e più in generale pre-industriali – la linea di pensiero che va da Mauss al MAUSS, passando per il fondamentale apporto di Karl Polanyi, consente di collocare la lezione marxiana in uno sfondo storico-antropologico ben più ampio e sopratutto di enucleare – a fianco dell’ineguaglianza – quella che possiamo ritenere una seconda dinamica sociale fondamentale. Tale dinamica ha che vedere con i processi mediante i quali gli esseri umani si organizzano in società, e quindi, per usare una formulazione semplificata, con il farsi e il dissolversi del legame sociale.
Secondo Polanyi il processo capitalistico, la grande trasformazione che la rivoluzione industriale ha portato con sé implica un duplice processo di mercificazione: i fattori di produzione, esseri umani e natura, devono essere ridotti a merci. La megamacchina lo richiede: il regolare approvvigionamento del lavoro e delle risorse naturali è infatti una necessità imprescindibile affinché il processo produttivo si svolga regolarmente, e sopratutto, gli enormi capitali investiti trovino una remunerazione adeguata e non troppo rischiosa. E’ così che tra Sette e Ottocento, prima in Inghilterra e poi sul continente, vengono a crearsi un mercato per le risorse naturali e sopratutto un mercato del lavoro. Che questo processo assomigli più a una metamorfosi, cioè , in termini sistemici, all’emergere di nuova forma di organizzazione sociale, che non a un processo di sviluppo “naturale e continuo” è stato sottolineato con forza dallo stesso Polanyi: mai, nelle organizzazione economico sociali del passato il lavoro era stato comprato e venduto come nell’Inghilterra di inizio Ottocento. Una serie di meccanismi istituzionali, di regole saldamente ancorate nella legge e nelle consuetudini, agivano, come sistemi di feedback negativo, impedendo che il lavoro, con tutto il portato di relazioni sociali e simboliche che esso porta con sé, potesse essere comprato e venduto sul mercato. Questo processo di riorganizzazione, fa sì che le relazioni di reciprocità su cui si fondavano i sistemi economico-sociali tradizionali vengano spezzati e sostituiti da scambi di merci. L’economia, per riprendere le parole del grande economista, avanza sulla desertificazione del sociale.
Secondo Polanyi questa “grande trasformazione” comporta l’emergere non solo di un nuovo tipo di economia ma di un nuovo tipo di società. In una prima fase essa richiede la rottura delle regole/relazioni che caratterizzavano il tipo di organizzazione sociale precedente e dei processi omeostatici che ne garantivano la stabilità. A ciò si accompagna il sorgere di una sfera ampiamente autonoma di relazioni relazioni economiche (di mercato) accompagnata da un successivo aumento della complessità in questa sfera (specializzazione del lavoro, ecc) che finisce per dominare e dare forma alle seconde.
E’ importante comprendere perché, mano a mano che il processo di trasformazione raggiunge una sua maturità e l’economia di mercato si diffonde in nuovi paesi ed e verso nuove società, questo processo comporti una progressiva dissoluzione dei legami sociali. Come hanno mostrato i pionieristici lavori di Malinowski e di Marcel Mauss, ciò che caratterizza le relazioni di reciprocità tipiche della società tradizionali è “il triplice obbligo di donare ricevere e ricambiare.” Su questo obbligo, attraverso la molteplicità di doni e contro doni, si fondano e si mantengono i legami sociali. Questa conclusione è oggi supportata da un’ampia serie di ricerche (A. Caillè, 1991, 1998 J.T. Godbout, 1993, 1998). Al contrario le relazioni di mercato si basano su quello che gli economisti definiscono “scambio di equivalenti.” L’equivalenza di ciò che viene scambiato consente alle relazioni di mercato di chiudersi nel momento in cui si effettua lo scambio, senza dunque che attorno ad essa si costruisca alcun legame tra gli individui. In altre parole le relazioni di mercato assumono un carattere impersonale: come disse sagacemente Milton Friedman, ideologo del neoliberismo della scuola di Chicago, “nel grande supermercato globale non occorre conoscersi né tanto meno essersi simpatici.” Certo questa norma fondativa del mercato presenta significativi vantaggi economici: essa ha consentito una straordinaria moltiplicazione del numero e della varietà dei beni scambiati: è stato calcolato che nella sola città di New York sono oggi disponibili 100 miliardi di diverse tipologie di beni. Ciò che normalmente non si dice, è che questa medaglia ha un suo rovescio: la diffusione delle relazioni di mercato si accompagna infatti ad una progressiva dissoluzione dei legami sociali.
Questo processo ha conosciuto una ulteriore accelerazione a partire dagli anni ’80 con l’affermarsi del neoliberismo e globalizzazione dei mercati, come ha riconosciuto la letteratura sociologica più recente. In particolare nella lettura offerta da Bauman (2002, 2006) la dissoluzione dei legami sociali, nel contesto della contemporaneità, si esprime sotto forma di liquidità sociale. Non a caso la società liquido-moderna è “una società di consumi”. Una società, cioè, in cui ogni cosa, beni e persone, sono trattati come oggetti di consumo e pertanto come qualcosa che perde utilità, attrazione, in definitiva valore, molto rapidamente. Pertanto la società liquida è una società mobile, impermanente, precaria, in cui tutto ciò che ha valore si trasforma rapidamente nel suo contrario, esseri umani inclusi. In definitiva, secondo la descrizione offerta da Bauman, la società moderna raggiunge livelli mai conosciuti prima di dissoluzione dei legami sociali.
Certo, come ci ricordano gli ottimisti, si osservano anche alcune dinamiche compensative. La scuola ed i nuovi sistemi di formazione e comunicazione consentono nuove forme di socialità. E’ possibile, inoltre, attribuire nuove funzioni agli oggetti e agli strumenti che fuoriescono dalla cornucopia capitalistica: usare la pubblicità contro la pubblicità (Adbuster, Casser de Pub), o le reti informatiche, originariamente progettate per scopi militari, per favorire la costruzione di reti sociali o solidali. Difficilmente, tuttavia, questi processi compensativi ci sembrano in grado di contrastare la forza dei processi di dissoluzione.
In conclusione la “dissoluzione dei legami sociali” tipica delle società liquido-moderne, oltre a spiegare una parte significativa della perdita di benessere che si regista in queste società a partire dalla metà degli anni Settanta (Bruni e Porta, 2004), offra una prima chiave interpretativa del perché, nonostante il depauperamento dell’ambiente e le forti e crescenti ineguaglianze sul piano economico e sociale, queste società si mostrino, anche nel contesto della crisi, così poco reattive. Tuttavia per poter affrontare adeguatamente questo aspetto occorre introdurre un’ulteriore dimensione: quella relativa all’immaginario.
Frammentazione post-moderna e immaginario dominante
Ciò che caratterizza i sistemi biologici e sociali e che li differenzia dai sistemi fisici, è la capacità di cui i primi dispongono di formarsi “rappresentazioni” dell’universo in cui vivono. Certamente anche gli animali sono in grado di farsi un’idea del mondo che li circonda, e di prendere decisioni a fronte di certi stimoli (signaling). Ad esempio, già organismi molto semplici, come gli organismi unicellulari sono in grado di stimare la presenza di un certo composto chimico in un fluido e di muoversi di conseguenza nella direzione in cui tale composto è maggiore. Tuttavia ciò che sembra specifico delle organizzazioni socio-culturali umane è la capacita di negoziare tali rappresentazioni, dando luogo a rappresentazioni condivise (D. Lane, D. Pumain, S. van der Leeuw, G. West, 2009).
A differenza di quanto accade nell’attività omologa nell’ambito dei sistemi biologici (signaling) nella negoziazione la semantica conta. Il messaggio può essere completamente nuovo nella forma e tuttavia colui che lo invia si aspetta che il ricevente sia in grado di interpretarlo. Affinché ciò possa accadere è molto importante che le organizzazioni socio culturali umane condividano “attribuzioni di valore” e “forme narrative” su cui i messaggi si basano. In altri termini, e più in generale, possiamo concludere che la formazione di un immaginario condiviso è la premessa necessaria affinché individui e organizzazioni sociali possano intraprendere un progetto o un’azione comune.
Ma, come argomenta Lyotard, con la fine della gradi narrazioni e l’avvento della società post moderna è precisamente questo orizzonte di senso condiviso che è venuto a mancare (Lyotard, 1979). Sino a quando la tradizione religiosa (il cristianesimo in occidente), il marxismo e altre “grandi narrazioni” offrivano un comune orizzonte di senso, con i loro eroi e i loro miti nei quali identificarsi, non era difficile per ciascuno prendere posizione nella società e dare un senso al proprio ruolo e alla propria azione. Tutto questo, quantomeno dagli anni Settanta, è scomparso, o comunque ha perso la sua presa sull’immaginario sociale [3].
L’immaginario postmoderno è un immaginario polimorfo, frammentato, dove la citazione prende il posto delle grandi narrazioni e la pluralità dei codici e delle forme narrative si sostituisce all’universalismo che caratterizzava il grande progetto emancipatorio della modernità. Per quanto la condizione post-moderna sia caratterizzata da una innegabile libertà e varietà di espressione, essa nasconde al tempo stesso le ragioni profonde della frammentazione e della dipendenza. Ma cerchiamo di tratteggiare, seppure seguendo un ragionamento “a grana grossa”, le dinamiche che possono essere ritenute responsabili di questo processo di trasformazione.
Rispetto ai processi di tempo lungo di cui abbiamo detto sopra, potremmo avanzare l’ipotesi che la frammentazione dell’immaginario sia connesso innanzitutto alla dissoluzione dei legami sociali che caratterizza il passaggio dalle società tradizionali alle società di mercato. In altre parole si può immaginare che la dissoluzione dei legami sociali di tipo tradizionale – e dell’apparato di simbolico che le è proprio – costituisca l’indispensabile premessa all’avanzare della modernità e dei suoi simboli.
Inoltre, come ha notato acutamente David Harvey (1990) occorre chiarire che la condizione post-moderna non si configura come rottura dalla modernità, quanto piuttosto come una “rivoluzione interna” alla modernità stessa, che finisce per accentuarne i tratti più profondi e caratterizzanti. L’esperienza comune alla modernità tutta da cosa è segnata, infatti, se non dall’incertezza e dalla frammentazione, dalla caducità e dal senso di cambiamento caotico? Nelle parole dei uno dei suoi massimi esperti “essere moderni vuol dire vuol dire trovarci in un ambiente che promette avventura, potere, gioa, crescita, trasformazione di noi stessi e del mondo e che al contempo minaccia di distruggere tutto ciò che abbiamo” (Berman, 1985, p. 25). In fondo il passaggio alla post modernità non ha fatto altro che accentuare questa tendenza.
Come non leggere qui la stretta connessione tra l’esperienza comune dell’essere moderni e le trasformazioni economiche e sociali sottostanti. Già Marx aveva sottolineato come un tratto fondamentale dell’economia capitalista fosse il sua condanna all’incessante innovazione. Harvey si spinge ancora oltre mostrando con chiarezza come la trasformazione che segna l’immaginario postmoderno sia connesso al passaggio dall’organizzazione economico sociale fordista a quella post-fordista. Va premesso che il post-fordismo come già il fordismo non rappresenta per Harvey semplicemente un sistema di organizzazione del lavoro, ma un nuovo sistema di organizzazione economica e sociale, in cui le istituzioni pubbliche e la società civile si adeguano alle mutate condizioni proprie “dell’accumulazione flessibile”. La scomparsa della grande fabbrica, la finanziarizzazione dei processi economici, la flessibilità sul mercato del lavoro (lavori a tempo parziale, temporanei o in subappalto), la centralità assunta dai servizi (di marketing, assicurativi, immobiliari, informatici); la straordinaria differenziazione dei prodotti e l’accelerazione nella rotazione dei consumi “ sono inseparabili da [quello] specifico modo vivere, di pensare, di sentire la vita” che definiamo post-moderno.
Semmai il fatto più sorprendente è la totale accettazione della liquidità e della frammentazione che caratterizza il postmodernismo: il suo “galleggiare e sguazzare nelle correnti caotiche del cambiamento quasi non ci fosse null’altro”. Non stupisce che Jameson definisca l’architettura postmoderna come “deliberata superficialità” e non sarebbe difficile estendere questo giudizio, in particolare alla moda, all’intrattenimento, all’industria degli eventi culturali.
Nel contesto della contemporaneità la frammentazione dell’immaginario è legata, inoltre, alla moltiplicazione degli artefatti che caratterizza la società dei consumi. E’ importante rendersi conto che gli oggetti di cui ci circondiamo, attraverso il tempo che spendiamo con loro e per loro, divengono per ciascuno strumenti con cui ciascuno costruisce la propria identità, per quanto angusta e frammentata. Non vi sono dubbi, e non entreremo in dettagli su questo, che le imprese impiegano molte risorse per alimentare questo processo. Il budget relativo a marketing e alla pubblicità è secondo solo a quello delle spese militari e come ben sanno gli esperti del settore, la potenza di fuoco del sistema mediatico è tale è tale che l’efficacia di una “campagna” non è mai messa in discussione. A differenza di quanto sostengono molti intellettuali post moderni, la capacita del sistema mediatico di colonizzare l’immaginario è enorme. Caos e frammentazione non devono dunque portarci a concludere che nella società liquida non esiste un immaginario dominante. Come ci avverte Serge Latouche questo sarebbe un grossolano errore: nella società dei legami deboli, l’immaginario consumista resta il solo collante condiviso (Latouche, 2007).
Indubbiamente l’homo consumens dispone oggi di una incredibile libertà di scelta. Tuttavia, il cittadino-consumatore può operare le proprie scelte solo all’interno di un set predefinito, non può determinare ex ante l’insieme delle cose fra cui può scegliere (Bauman, 2002; 2006). E fra queste c’è senz’altro la tecnologia, ossia il come della produzione. In altre parole il sistema di mercato promette libertà, ma veicola dipendenza. Arriviamo qui ad un aspetto fondamentale: è chiaro che la questione dell’immaginario si lega strettamente a quella dell’autonomia/dipendenza (Castoriadis, 1998, 2005) [4].
In conclusione la condizione dell’immaginario post-moderno sembra segnata dalla compresenza di due polarità apparentemente contraddittorie: individualizzazione e omologazione. Da un lato sembra chiaro che la frammentazione dell’immaginario rende impossibile una presa d’atto collettiva delle contraddizioni in cui il sistema è intrappolato e, di conseguenza, estremamente difficile un’azione coordinata in questa direzione. L’esperienza del movimento contro la globalizzazione e da questo punto di vista illuminante. Dall’altro ci si potrebbe chiedere come mai una società che pure conosce un grado di libertà individuale apparentemente così elevato, è in realtà così conformista nelle decisioni collettive. Ho il sospetto che ancora una volta la spiegazione possa essere ricercata nella scala del processi. La frammentazione del legame sociale e la straordinaria concentrazione delle ricchezza legati all’espansione dell’economia a scala globale ha reso possibili, ed efficaci, strumenti di condizionamento dell’immaginario collettivo funzionali alla creazione di un uomo massa che non avrebbero senso, né potrebbero essere mantenuti, a scale più ridotte. Tali strumenti stanno mostrando tutta la loro efficacia nell’impedire di squarciare il velo che occulta la connessione tra la libertà nelle scelte di consumo individuali e l’oppressione della gabbia collettiva.
Crisi e rendimenti decrescenti
Ritorniamo dunque al contesto della crisi attuale. I processi che abbiamo analizzato possono esserci d’aiuto per comprendere la dinamica della crisi? Innanzitutto cosa l’ha scatenata? Interpellati, con alcune rarissime eccezioni, le molte migliaia di economisti che nulla avevano detto sull’avvento della crisi, ci hanno ripetuto in infinite versioni la storia dei mutui sub prime, riconducendo la crisi agli eccessi nella concessione del credito del mercato americano. E’ noto che le regole che presiedono alla concessione e moltiplicazione del credito, in particolare per i così detti derivati, sono eccessivamente lasche… non a caso è su questa deregolamentazione si è costruita la fortuna del capitalismo finanziario degli ultimi trent’anni. Tuttavia le cose sono probabilmente più complesse di così.
Innanzi tutto va chiarito che, fra i sistemi che abbiamo analizzato, quello finanziario è certamente il più sensibile. Gli agenti formano le loro aspettative a partire da un’ampia serie di segnali. A differenza di quanto accade nei sistemi sociali o nella biosfera, i sistemi finanziari dispongono di indici che riportano minuto per minuto l’andamento dei mercati, e questo fa si che, quando si scateno eventi eccezionali, si inneschi un processo di feedback positivo (effetto panico) tra l’andamento degli indici e il comportamento degli agenti che amplifica notevolmente le oscillazioni. Questo chiarisce perché il sistema finanziario sia più veloce e sensibile di altri nelle sue oscillazioni e perché le crisi nei tempi moderni si manifestano generalmente a partire dal collasso delle borse. L’esplosione della bolla speculativa si trasferisce poi, inevitabilmente, all’economia reale.
Resta aperta la domanda: che cosa ha scatenato la crisi? Joan Martinez Alier, economista ed ex Presidente dell’International Society of Ecological Economics, ha avanzato l’ipotesi che la crisi finanziaria sia stata innescata dall’eccessivo aumento del prezzo del petrolio, che raggiunse i 140 $ il barile nel Luglio del 2008, mettendo in crisi le aspettative di profitto, in particolare del mercato americano dell’auto. Alcune ricerche più recenti sembrano confermare questa ipotesi (Hamilton, 2009). Ma se le cose stanno in questi termini quella a cui stiamo assistendo potrebbe rappresentare non solamente la crisi economica più grave degli ultimi settanta anni, ma un primo segnale di una crisi di sistema.
Dall’economia reale la crisi si è poi trasferita alla società. Novanta milioni di persone scivolano sotto la soglia dei due dollari al giorno secondo le stime della Banca Mondiale. I disoccupati si contano a decine di milioni in Europa. Conformemente alla lezione polanyiana, la società reagisce alla crisi auto difendendosi: neoprotezionismo, difesa delle banche e dei grandi gruppi, richieste di protezione sociale e salariale, sono tutte forme in cui si è espressa l’autodifesa della società. Tuttavia essa prende soprattutto la forma di una richiesta di intervento protettivo dello Stato nei confronti degli shock provenienti dai mercati. Non a caso, nonostante le differenze politiche, dall’America di Obama, all’Italia berlusconiana, dalla Cina “comunista” all’Inghilterra, i governi e le banche centrali intervengono, certo con misure a volte parziali e discutibili, ma comunque intervengono, iniettando nel sistema enormi ammontari di liquidità, in misura assai più significativa di quanto avvenne negli anni ’30.
Tuttavia, considerata la gravità della situazione economica e sociale, ci si domanda come mai i conflitti siano tutto sommato contenuti e scarsa la capacità di reazione della società. Secondo quanto visto in precedenza ciò può essere legato a due fattori principali: Nel nord ricco del pianeta, il calo dei redditi è molto forte, ma la ricchezza accumulata durante i decenni della crescita economica, per quanto mal distribuita, è molto maggiore di quanto fosse negli anni Trenta. Inoltre le politiche monetarie e fiscale messe in atto dai governi, hanno impedito il tracollo del sistema finanziario e sostengono in culche modo la domanda, pur trsferendo il peso dell’operazione sulle genrerazioni future, già gravate di un debito enorme e in via di espansione. Inoltre, se escludiamo alcune minoranze consapevoli e attive, i fattori di liquidità sociale e di frammentazione dell’immaginario collettivo di cui si e detto, ostacolano fortemente il coagularsi di un progetto alternativo e dunque l’autorganizzazione della società.
Certo è possibile che nel medio periodo le economie avanzate tornino a conoscere – per qualche tempo – di crescita dell’ordine dell’uno due per cento, ma questo significa forse che la crisi di sistema sia risolta?
In un suo recente articolo lo storico ed economista Immanuel Wallerstein (2009), che da tempo segue un approccio sistemico, avanza l’ipotesi che il sistema capitalista non sia di fronte ad una, per quanto grave, crisi ciclica, ma, appunto ad una crisi di sistema. Questo non implica, nella prospettiva di Wallerstein, che il sistema economico non possa conoscere un qualche ripresa a breve quanto, piuttosto, che nei prossimi 20-30 anni l’aumento dei costi necessari per alimentare il processo di produzione – essenzialmente costi del lavoro, delle materie prime/energia e costi relativi all’apparato statale e militare (e dunque delle tasse) – impedirà una nuova fase di crescita ed accumulazione globale di lungo periodo, determinando la fine del modo di produzione capitalistico così come lo abbiamo conosciuto sino ad oggi. Certo si tratta di un’ipotesi, per altro non nuova nell’ambito delle teorie di derivazione marxista, e che tuttavia Wallerstein ha avuto il merito di presentare ben prima dell’affacciarsi della crisi. E’ interessante notare – al di la un certo riduzionismo economico (le varie dimensioni della crisi sono infatti tutte ricondotte in termini di costi economici) – le affinità tra l’analisi di Wallerstein e l’approccio sviluppato, in una cornice ben diversa, dall’archeologo e studioso di sistemi complessi, Joseph Tainter nel suo Il collasso delle società complesse (1988). Analizzando i processi di decadenza delle più importanti civiltà della storia (l’Impero romano, la civiltà Maya, l’isola di Pasqua, e numerosi altri) Tainter individua un principio comune a tutti questi casi. Al crescere della complessità delle strutture economico-sociali, oltre una certa soglia, i benefici della complessità presentano incrementi decrescenti. Pertanto, superata una certa soglia di complessità, queste megamacchine (eserciti, burocrazie, corporazioni) cominciano a presentare costi che superano i benefici. Tesi nel tentavo di superare i problemi che queste stesse strutture generano, coloro che le governano possono essere spinti ad ignorare i segnali che preannunciano una crisi di sistema, (come appunto un aumento dei “costi” – non intesi qui in senso strettamente economicistico – provenienti dai vari sottosistemi) e, sviati da alcuni comportamenti tipici dei sistemi complessi, (come incertezza delle informazioni, ritardi di feedback, ecc.) spingere verso un’ulteriore espansione, fino al collasso del sistema.
Questo è solo uno dei possibili scenari ipotizzabili (Raskin, 2008), tuttavia è chiaro che i processi di lungo periodo che abbiamo analizzato – e che trovano nella crescita ed accumulazione illimitata la loro radice comune – si possono inscrivere facilmente in questa cornice interpretativa.
Al momento l’ipotesi di Wallerstein, che prevede appunto una aumento delle varie dimensioni del costo di produzione (lavoro, risorse, tassazione) non mi pare trovi riscontri empirici sufficienti a trarre conclusioni definitive (anche per la tragica mancanza di ricerche sistematiche in merito), tuttavia è evidente che se il quadro complessivo risultasse fondato, da una crisi di questa natura non si esce certo con qualche iniezione di keynesianesimo verde, finanziato tra l’altro con la creazione di nuovo debito. E’ ormai sempre più evidente che dalla crisi si esce solo con un nuovo progetto di società e dunque con una profonda revisione delle principali istituzioni che governano la società attuale.
Corrispondenza a: mauro.bonaiuti chiocciola unito.it
[2] Cfr. B. S. FREY, A. STUTZER, Happiness and Economics. How the Economy and Institutions Affect Well-being. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 2002. E. DIENER, R. BISWAS-DIENER, Will Money Increase Subjective Well-being? Social Indicator Research, vol. 57, n. 2, pp. 119-169, 2002. In lingua italiana vedi anche l’ottima raccolta di testi a cura di LUIGINO BRUNI E PIER LUIGI PORTA, Felicità ed economia, Edizioni Guerini e Associati, Milano, 2004.
[3] L´immaginario sociale è la modalità specifica con cui una società riproduce la rappresentazione di se stessa e fonda in essa la sua identità. L´immaginario sociale si struttura dunque come un campo di significati che consente a una società di riconoscersi nell´immagine del mondo che essa stessa ha elaborato, ma esso permane nel tempo lungo come se non avesse una origine e fosse una costellazione di simboli senza tempo.
[4] Porre da sé le proprie leggi, autodeterminazione, autoistituzione esplicita, questo è il significato fondamentale di ciò che intendiamo per autonomia. Ivan Illich (1974) preferiva l’espressione convivialità ma l’idea di fondo non era diversa: la società conviviale è la società che mantiene il controllo dei propri strumenti, in altre parole che decide come e cosa produrre senza delegarne la decisione ad esperti o a rappresentanti.
Bibliografia
Braudel F., 1981. La dinamica del capitalismo, Il Mulino, Bologna.
Bruni L., Zamagni S., 2004, Economia Civile, Il Mulino, Bologna.
Bruni L., Porta P.L. (a cura di), 2004, Felicità ed economia, ed. Guerini, Milano.
Caillé A., 1998. Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono, Bollati-Boringhieri, Torino.
Caillé A., 1991. Critica della ragione utilitaria, Bollati Boringhieri, Torino.
Castoriadis C.,1995. L’istituzione immaginaria della società. Bollati Boringhieri, Torino.
Castoriadis C., 2005. Une société à la dérive, ed. Du Seuil, Paris.
Castoriadis C., 1998, L’enigma del soggetto, ed. Dedalo, Bari.
Chambers, C. Simmons, M. Wackernagel, 2000. Sharing Nature’s Interest. Ecological Footprints as an indicator of Sustainability, Earthscan Pub., tr. it. Manuale delle impronte ecologiche, Ed. Ambiente, Milano, 2002.
Dierckxsen W., 2006, La transizione al postcapitalismo, Grafo, Brescia.
Fotopoulos T., 1999. Per una democrazia globale. Elèuthera, Milano.
Gallino L., 2003. La scomparsa dell’Italia industriale, Einaudi, Torino.
Georgescu-Roegen, N. 1971. The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge, Mass, Harvard University Press.
Georgescu-Roegen N., 2003. Bioeconomia. (a cura di M. Bonaiuti), Bollati-Boringhieri, Torino.
Ginsborg P., 2006. La democrazia che non c’è, Einaudi, Torino.
Godbout J.T., 1998. Il linguaggio del dono, Bollati Boringhieri, Torino.
Godbout J.T.,1993. Lo spirito del dono, Bollati Boringhieri, Torino.
Haldane J.B.S., Della misura giusta e altri saggi, Garzanti, Milano.
Hamilton J.D., 2009. Causes and Consequences of the Oil Shock 2007-2008, Brookings Papers, D. Romer and J. Wolfer Eds. www.brookings.edu
Hirsch F., 1981. I limiti sociali allo sviluppo, ed. Fabbri-Bompiani, Milano.
Hopkins T. K., Wallerstein I., 1997, L’era della transizione, Asterios, Trieste
Illich I., 1974. La convivialità, Mondadori, Milano.
Illich I., 1994. Conversazioni con Ivan Illich, a cura di D. Cayley, Eléuthera, Milano.
Lane D., Pumain D., S. van der Leeuw, G. West, eds. 2009. Complexity Perspectives in Innovation and Social Change, Springer-Verlag, Berlin.
Latouche S., 1992. L’occidentalizzazione del mondo, Bollati Boringhieri, Torino.
Latouche S., 1993. Il pianeta dei naufraghi, Bollati Boringhieri, Torino.
Latouche S., 1995. La megamacchina, Bollati Boringhieri, Torino.
Latouche S., 1997. L’altra Africa, Bollati Boringhieri, Torino.
Latouche S., 2003. Giustizia senza limiti, Bollati Boringhieri, Torino.
Latouche S., 2007 La scommessa della decrescita, Feltrinelli, Milano.
Lyotard J.F., 1979. La condition postmoderne: rapport sur le savoir, Minuit, Paris.
Maddison A., 2005. Growth and Interaction in the world economy, The AEI Press, Washington D. C.
Maddison A., 2009. Statistics on World Population, GDP and Per Capita GDP, 1-2006, in www.ggdc.net/maddison
Martinez-Alier J., 2002, The Environmentalism of the Poor, E. Elgard , Massachusetts, USA, tr. it. Ecologia dei poveri, Jaka Book, Milano, 2009.
Martinez-Alier J., 1987. Economia Ecologica, Garzanti, Milano.
Mauss M., 1965. Saggio sul dono, Einaudi, Torino.
Meadows D. e D. Randes J.,2006, I nuovi limiti dello sviluppo, Mondadori, Milano.
Polanyi K., 1944, 1974. La grande trasformazione, Einaudi, Torino.
Prigogine I., 1997. La fine delle certezze, Bollati Boringheri, Torino.
Raskin P. D., 2008. World lines: A framework for exploring global pathways, Ecological Economics, 65, 2008.
Rist G., 1997, Lo sviluppo. Storia di un’idea occidentale. Bollati Boringhieri, Torino.
Sachs W., 2002. Ambiente e giustizia sociale, Editori Riuniti, Roma.
Sachs W., 2007. Per un futuro equo. Conflitti per le risorse e giustizia globale. Feltrinelli, Milano.
Schumacher F., 1978. Piccolo è bello, Mondadori, Milano.
Tainter J. A., 1988. The collapse of complex societies, Cambridge University Press.
UNDP. 2002. Rapporto sullo sviluppo umano, Rosenberg e Sellier, Torino.
Wallerstein I., (1978, 1982, 1995) Il sistema mondiale dell’economia moderna, (Tre vol.), Il Mulino, Bologna.
Wallerstein I., 2000. Capitalismo storico e civiltà capitalistica, Asterios Editore.
Wallerstein I., 2002. Navigando nella tranzisione, Prospettiva Edizioni.
Wallerstein I., 2009. Capitalism’s Demise, The Asia-Pacific Journal, 2-1-09, in: http://www.energybulletin.net/node/47691