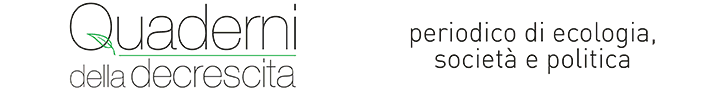Condividiamo l’intervista di Verdiana Fronza ed Ettore Barili a Daniele Vico, attivista e dottorando in economia ecologica, pubblicata anche su www.duegradi.eu
Che cos’è la decrescita? Questa è la domanda che abbiamo investigato in un recente articolo su Duegradi. Si tratta di un tema sfaccettato, con implicazioni profonde e sistemiche. Per questo abbiamo deciso di approfondire alcuni degli aspetti più spinosi della questione con qualcuno che di decrescita si occupa in prima persona: Daniele Vico è dottorando in Economic History and Development presso il Political Ecology Lab della Facoltà di Economia e Impresa dell’Università di Barcellona, e volontario dell’associazione Research & Degrowth.
La sua ricerca affonda le radici in due discipline: l’economia ecologica, che vede l’economia come sotto-sistema sociale inserito in un più ampio ecosistema naturale, e l’ecologia politica, che si occupa di osservare le dinamiche di potere e di conflitto nella distribuzione delle conseguenze negative e positivi della gestione delle risorse ambientali. Nello specifico, Daniele si occupa di rifiuti e in particolar modo di pratiche di riciclo informale: il cosiddetto waste picking. Si tratta di una pratica lavorativa, appannaggio quasi esclusivo di persone marginalizzate, che consiste nel raccogliere e dividere a mano informalmente i rifiuti e le materie riciclabili per venderle all’industria del riciclo. Il waste picking , già molto diffuso nel Sud del mondo, si sta ora diffondendo anche nel Nord globale, e il dottorato di Daniele studia i riciclatori informali nella città di Barcellona. Quanto segue è il risultato dell’intervista.
Ti occupi di studiare pratiche informali di riciclo: in che modo la tua ricerca è legata al tema della decrescita?
Il waste picking è una pratica interessante in un’ottica di decrescita: la mia idea è che questa pratica, per quanto socialmente stigmatizzata e precaria, possa essere un esempio di riciclo veramente sostenibile, in quanto basata su metodi a bassa intensità tecnologica. Il waste picking non prevede infatti l’utilizzo di tecnologie raffinate e risulta quindi in linea con l’idea della decrescita secondo cui la tecnologia deve essere ridimensionata e rimessa al servizio di una vera sostenibilità.
Qual è secondo te lo stato dell’arte della pratica decrescentista?
La mia impressione è che nel tempo ci sia stato un passaggio dal livello micro al livello macro nell’approccio e nell’analisi delle teorie decrescentiste. La decrescita delle origini era più focalizzata sul ruolo del consumatore, sulle pratiche individuali, mentre adesso questo è accompagnato da un’attenzione maggiore ai sistemi socioeconomici e a come cambiarli. Credo che in qualche misura la “prima decrescita” abbia risentito, inconsciamente, della pervasività dell’ideologia neoliberista , fortemente egemonica in quel periodo, che portava a porre tutta l’attenzione dell’economia e della politica sul ruolo dell’individuo (prima di tutto e soprattutto consumatore). Il fatto che si torni a parlare di sistemi complessi (il macro) e dell’idea che alcuni attori economici hanno più potere dei singoli individui è dovuto a un cambiamento dei tempi. Credo sia un’ottima cosa.
L’altra novità degli ultimi dieci anni è il fatto che la decrescita è ora supportata accademicamente da argomenti molto solidi. Nata come slogan di attivismo, la teoria della decrescita può avvalersi ora di una diagnosi molto chiara e solida del problema, e concentrarsi sulle strategie politiche da attuare, sia per portare la decrescita nel campo del politicamente possibile (e desiderabile), sia per applicarla nel concreto. Il tema della strategia, ad esempio, è stato affrontato in maniera organica in un libro pubblicato nel 2022 intitolato “Degrowth and Strategy”. Altri libri fondamentali pubblicati recentemente, che riflettono sulle politiche necessarie per la decrescita, sono “The case for degrowth” (che pare verrà presto tradotto in Italiano) e “Less is More” (da poco tradotto in italiano con il titolo di “Siamo ancora in tempo!”).
Un’altra novità è che il dibattito sulla decrescita ha iniziato ad affrontare la questione coloniale. Questo è un punto da sottolineare, perchè spesso male interpretato: la decrescita si riferisce alle nazioni del Nord Globale, alle nazioni industrializzate, e lo fa per due motivi. Il primo è che le nazioni industrializzate, in quasi tutti i casi, sono le nazioni che attualmente hanno i più alti consumi di energia e materiali. Il secondo è che la loro industrializzazione porta con sé una responsabilità storica nella crisi climatica in cui ci troviamo oggi. Jason Hickel, nel suo libro Less is More, How Degrowth Will Save the World, sottolinea come le nazioni del Nord Globale sono responsabili per il 92% della CO2 in eccesso nell’atmosfera. È quindi un atteggiamento colonialista sostenere che nessun paese, neanche quelli a basso reddito, deve più emettere CO2 a partire da subito.
Sia chiaro però: la decrescita non teorizza che i paesi a basso reddito debbano seguire lo stesso percorso di cosiddetto “sviluppo” dei paesi industrializzati. Il discorso sulla responsabilità si accompagna a quello sulla decolonizzazione politico-economica. Chi studia e porta avanti l’idea della decrescita ritiene che il sistema geopolitico internazionale, strutturato ancora oggi con dinamiche neocoloniali nei confronti del Sud Globale, è eticamente e politicamente sbagliato. A partire dal dopoguerra sono infatti state imposte ricette di sviluppo che comportavano una completa e veloce industrializzazione, e l’imposizione di modelli socio-economici funzionali all’estrazione di risorse, implicitamente a favore delle economie del Nord Globale. Questo ha spesso portato alla distruzione delle economie locali. Attuare la decrescita significa quindi attuare una completa decolonizzazione, sia nella pratica, che liberi i paesi del Sud Globale da accordi economici iniqui ed estrattivi, sia del concetto nell’immaginario politico: sradicare l’idea che un paese si “sviluppa” solo quando persegue la crescita economica. Costruite queste basi, ogni paese potrà autodeterminare il percorso sociale e politico più adatto ai propri bisogni.
Esistono esempi concreti di applicazione di politiche decrescentiste? Su che scala risultano più praticabili le strategie di decrescita?
Si stanno attuando pratiche e politiche riconducibili alla decrescita più o meno a tutti i livelli, anche in maniera abbastanza concreta e in alcuni casi inconsapevole. A un livello più micro, ci sono esempi di adozione consapevole di pratiche decrescentiste come i living labs sparsi in giro per l’Europa, piccole comunità che cercano di vivere secondo le pratiche della decrescita quotidiana. Un esempio su tutti è Can Decreix, un living lab sui Pirenei al confine tra Francia e Spagna.
Ci sono poi altri livelli di implementazione di politiche di decrescita: alcune comunità hanno esplicitamente eliminato la crescita dai loro obiettivi, come tutte quelle città che in questo momento stanno cercando di applicare il famoso modello dell’economia della ciambella di Kate Raworth, le doughnut cities. I governi di queste città stanno sviluppando degli indicatori di benessere urbano ambientali e sociali da sostituire alla crescita economica come indicatore di sviluppo. Alcuni esempi sono Amsterdam, Barcelona, Grenoble: magari non menzionano la decrescita, ma la applicano.
Abbiamo sia pratiche che politiche che stanno applicando principi relativi alla decrescita senza saperlo. Partendo dal basso, c’è tutto il mondo dell’economia sociale e solidale, sostanzialmente un grandissimo ecosistema di modelli organizzativi e imprenditoriali che cercano di limitare l’importanza del profitto all’interno dell’impresa, accompagnandola (o sostituendola!) con altri obiettivi come la sostenibilità ambientale e sociale.
Anche proposte di politiche macroeconomiche come la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, il reddito di base e l’abolizione delle privatizzazioni nei servizi essenziali si collocano in ambito di decrescita.
Quindi le strategie di decrescita possono essere applicate a tutti i livelli di governance. L’ostacolo maggiore non è una praticabilità “concreta”, ma ideologica, dal momento che alcune idee suscitano ancora oggi diffidenza. C’è chi dice che la parola decrescita fa paura e che parte del pubblico, leggendola, se ne allontani temendo un ritorno all’età della pietra.
Altri sostengono invece che usare questo termine sia utile ed efficace perché stimola il dibattito, ed è inoltre difficile appropriarsene per fini politici. Ho l’impressione che abbiamo assistito negli ultimi anni all’appropriazione da parte della politica di una serie di termini che una volta erano molto più radicali, come “sostenibilità” e “resilienza”. O anche, per citare un corto circuito nostrano, “sovranità alimentare”. Ormai, il bollino sostenibilità lo puoi mettere su qualsiasi cosa e fare greenwashing. Ma non ci si è ancora appropriati del termine decrescita e forse è davvero impossibile farlo.
Una delle critiche comunemente avanzate al modello di decrescita è che prefigurerebbe un mondo poco desiderabile in cui ci sarebbero preclusi alcuni beni e attività. Cosa si risponde a questa critica? Si può rendere desiderabile per i più la riduzione dei consumi e della produzione?
Occorre fare una piccola premessa: stiamo già andando nella direzione di contrazione della produzione di beni e servizi, e della crescita economica in generale, e non volontariamente. La crisi climatica e il superamento di tipping points negli ecosistemi porteranno a un collasso di parti del nostro sistema socioeconomico. In ogni caso arriveremo a un punto in cui non avremo più le risorse per espandere la produzione di beni e servizi, limitata anche dai cambiamenti climatici. Quello che dobbiamo chiederci è se vogliamo che ci succeda in maniera imprevedibile e improvvisa, oppure se vogliamo gestire questa traiettoria in maniera controllata, limitando al minimo gli impatti negativi: se in un modo o nell’altro dovremo affrontare una decrescita, la domanda è in che modo vogliamo farlo.
Quando i combustibili fossili, da cui il nostro sistema produttivo dipende, finiranno, non si potranno più sostenere gli attuali ritmi di produzione. Per il momento, le energie rinnovabili hanno un ritorno energetico sull’investimento più basso dei combustibili fossili, sono meno efficienti. Inoltre, anche per la produzione di energie rinnovabili c’è un discorso di materiali necessari per produrre e mantenere le infrastrutture che trasformano l’energia. Chiariamoci: abbiamo bisogno di una transizione totale alle rinnovabili nel minor tempo possibile. Ma non basterà, se pretendiamo di mantenere o addirittura espandere gli attuali livelli di domanda di energia.
Io credo che la decrescita sia desiderabile come società perché è una proposta per ridurre l’impatto negativo dei cambiamenti climatici, cercando al tempo stesso di migliorare la vita della maggioranza delle persone. Per comprendere meglio ciò che la decrescita propone, occorre però sfatare alcuni miti. Come citato nel vostro articolo, oltre un certo livello di reddito, a un aumento della ricchezza individuale non segue necessariamente un aumento della felicità. L’economista Tim Jackson spiega questo fenomeno parlando di beni posizionali, beni che le persone non acquistano per soddisfare un bisogno, ma perché essi accreditano l’appartenenza a un determinato ceto sociale.
Nelle società industrializzate ci siamo ridotti a basare il nostro benessere e conseguentemente il nostro malessere su questi beni. Anche se i nostri bisogni essenziali possono essere soddisfatti, basiamo il nostro benessere su dei bisogni indotti. La decrescita propone un taglio ai bisogni indotti (cambiare il cellulare ogni anno, comprare macchine più grandi e potenti, ecc.) e ai relativi settori. Un esempio classico è l’industria del lusso, un’industria che produce beni totalmente posizionali che l’80/90% della popolazione non si può permettere.
Soddisfare i bisogni e servizi essenziali è invece necessario. Per esempio, se abbiamo una sanità che ci cura senza impattare sul nostro salario, un’istruzione gratuita, la possibilità di muoverci spendendo poco siamo più sereni. La decrescita dice: tagliamo sui settori che non servono, tagliamo sui bisogni indotti e investiamo di più sul garantire a tutti i servizi che ci rendono davvero felici, i servizi che rispondono davvero ai bisogni essenziali delle persone.
L’economia neoclassica si fonda sul concetto di scarsità. Sostiene che viviamo in un sistema di risorse scarse e che dobbiamo quindi trovare il modo di allocare queste risorse nel modo più efficiente possibile. I teorici della decrescita sostengono che questo concetto è sostanzialmente inventato, è artificioso. Viviamo in un momento storico in cui non abbiamo mai avuto così tanta ricchezza. Il problema è dove questa ricchezza è allocata all’interno del sistema. Sempre Hickel, nel suo ultimo libro, ci fa vedere come la nuova ricchezza prodotta negli ultimi anni si è accumulata totalmente nelle mani di pochissime persone. Hickel e altri propongono di sostituire questo concetto di “scarsità artificiale” con quello di “abbondanza radicale”: c’è abbondanza di risorse, ma vanno ridistribuite: se noi redistribuiamo le risorse all’interno del sistema, questi bisogni essenziali possono essere soddisfatti, e possiamo garantirli virtualmente a tutte le persone, che al momento ne sono escluse. Quindi la decrescita in realtà è desiderabile per la maggior parte delle persone.
C’è un filone di ricerca molto interessante sui provisioning system, cioè sistemi con cui le società provvedono alla soddisfazione di determinati bisogni essenziali. Per esempio, per soddisfare il bisogno di cure mediche in un sistema socioeconomico possiamo intraprendere strategie diverse, in un continuum che va dalla sanità totalmente privata alla sanità totalmente pubblica. Molto spesso i provisioning system con un impatto ambientale più basso sono quelli basati sui beni pubblici. La decrescita dice: torniamo ad avere dei provisioning system di questo tipo in quanto sono tendenzialmente meno impattanti sull’ambiente, oltre a essere più egualitari. Per quanto riguarda il viaggiare, qual è il sistema più ecologicamente compatibile che può soddisfare questo bisogno? I treni veloci ed efficienti. Più che fare a meno di certe cose, è necessario cambiare il modo in cui garantiamo alla persone di fare le cose. Non esiste il diritto a prendere l’aereo, ma il diritto a spostarsi. Cerchiamo di garantirlo con il sistema il più inclusivo e ambientalmente sostenibile possibile.
Non è problematico dettare dall’alto i bisogni? Come si può imporre alle persone di non avere tutta una serie di desideri entrando nella loro sfera personale?
Credo che noi come società dobbiamo fare delle scelte collettive su come vogliamo vivere. Quanto sto per dire è una mia opinione: quest’idea che qualsiasi cosa è desiderabile e quindi debba essere soddisfatta, in realtà è un’altra truffa intellettuale del neoliberismo. Di recente è uscito uno studio che analizza le emissioni di CO2 pro capite dei cittadini statunitensi sulla base del loro reddito e che ci dimostra che l’1% dei più ricchi emette 22 volte più CO2 della famiglia media degli Stati Uniti. Questo lo ha detto anche OXFAM nel suo rapporto del 2020: i ricchi inquinano molto di più. La domanda è: è un loro diritto? La mia risposta e quella di molte altre persone nell’ambito della decrescita è che non lo sia. Anzi, se c’è un diritto è quello a un’aria pulita e un clima stabile. Quindi, anche a livello etico, non credo che esista il diritto ad avere consumi insostenibili, che privano le altre persone di risorse necessarie ai loro bisogni primari.
Si può creare un movimento culturale intorno a tematiche e stili di vita apparentemente poco attraenti?
È possibile e sta già succedendo. Esempi di questo tipo li abbiamo già visti in passato. In Germania quest’estate i biglietti dei treni sono stati messi a 9 euro al mese, in Spagna sta succedendo la stessa cosa, su scala più ridotta hanno avviato le sperimentazioni per avere i treni a corta percorrenza gratis. Chi prende i treni a corta percorrenza? Un pendolare che finora è andato in macchina perché il treno gli costava troppo. Certo, la decrescita suggerisce che certi consumi “estremi”, ad esempio i jet privati, debbano essere vietati. Però in realtà anche senza arrivare al divieto in molti casi è possibile cambiare gli stili di consumo delle persone. Basta rendere l’alternativa più sostenibile e più semplice da adottare.
La decrescita riflette molto anche sul ruolo della pubblicità nell’induzione di certi bisogni. Adesso diamo per scontato e riteniamo giusto che in TV non ci sia più la pubblicità delle sigarette, ma non è sempre stato così. É stata attivamente vietata dallo Stato, che può quindi contribuire a influenzare diverse abitudini di consumo. Il caso dell’utilizzo della bicicletta in Olanda è emblematico. Si possono indurre dei cambiamenti nello stile di vita delle persone senza peggiorarlo, anzi spesso migliorandolo. In questo processo però lo Stato non deve essere da solo. Il ruolo di iniziative dal basso, movimenti e gruppi di interesse è essenziale per influenzare cambiamenti nell’opinione pubblica che poi vengono recepiti, istituzionalizzati attraverso la politica.
Politiche di più forte distribuzione della ricchezza e di contenimento della produzione di alcuni beni e servizi potrebbero favorire la delocalizzazione di alcune imprese. In che modo il modello decrescentista tiene conto delle potenziali “esternalità negative” delle sue politiche sul lavoro?
La decrescita riflette sulle problematiche della globalizzazione per come è strutturata adesso. Il fatto che aziende e capitali possano uscire da un paese con facilità, che è una delle caratteristiche della globalizzazione economico-finanziaria, è problematico ed è un’altra faccia dell’ossessione per la crescita.
Riguardo il lavoro: è vero che riducendo la produzione di determinati beni o servizi o addirittura eliminando determinati settori, nel breve termine si rischia di aumentare il livello di disoccupazione. Chi studia la decrescita e le politiche del lavoro ha in mente due strategie principali per gestire questa cosa. La prima è la riduzione dell’orario di lavoro, strategia che non ha inventato la decrescita, ma che già esiste e che è stata teorizzata come contrasto alla disoccupazione con l’idea, in termini semplici, di far lavorare meno le persone per far lavorare più persone.
Questa cosa a livello economico si può fare ribilanciando l’allocazione del valore prodotto attraverso il lavoro. Nel nostro sistema molto del valore prodotto dal lavoro è appropriato dai cosiddetti proprietari del capitale: se noi andiamo a distribuire diversamente il modo in cui il valore prodotto viene distribuito nella società, che poi è quello che dovremmo fare in ottica di riduzione delle diseguaglianze, possiamo ridurre l’orario di lavoro a parità di salario. Una politica già in sperimentazione in vari Paesi.
Politica complementare è il reddito di base. Forse è il momento di ripensare l’idea che il reddito debba essere completamente collegato al lavoro, e riflettere sul fatto che il reddito possa essere un diritto di base delle persone, a prescindere dal fatto che stiano lavorando, per il semplice fatto che esistono e devono sopravvivere. Una prospettiva del genere permetterebbe alle persone di rimanere disoccupate senza morire di fame, e di lavorare meno, liberando quindi ore di lavoro che possono essere occupate da persone che invece vogliono lavorare.
Il reddito di base si può fare in duemila salse diverse. Quello che avevamo in Italia durante la pandemia, il cosiddetto reddito di cittadinanza, era una timidissima manovra in direzione di questa idea, anche se era subordinata all’idea che le persone tornassero a lavorare. Però ci sono altre proposte, che auspicabilmente si stanno facendo spazio nella scena politica di alcuni paesi, è di dare un reddito a chiunque a prescindere dal fatto che questa persona lavori o no. Di nuovo, le risorse nel sistema ci sarebbero per farlo. Ci sono sperimentazioni sul reddito di base in vari Paesi europei come Spagna, Francia, Svezia che cercano di raccogliere dati sugli effetti economici, sociali e ambientali di tali misure.
Poi la decrescita solleva altre questioni. Una variante particolare del reddito di base è quella del reddito non monetario, ovvero: se si riuscisse a rendere veramente gratuita tutta una serie di servizi, in qualche modo è come se si stesse dando del reddito alle persone, perchè in pratica si “libera” reddito che esse possono spendere in altri modi. Credo che qualsiasi nucleo familiare che tenga due conti in casa si renda conto di quanto gli costino la sanità, i trasporti, l’istruzione, e di quanto reddito sia dunque occupato per queste cose.
Un ulteriore elemento che i teorici della decrescita propongono è la rivalorizzazione di attività produttive che in questo momento non sono calcolate, come tutte le attività che afferiscono alla cosiddetta “cura”. Penso per esempio al lavoro di cura familiare di cui membri delle famiglia, spesso donne, si fanno carico. Oppure, ci sono anche statistiche sul terzo settore in Italia che dimostrano quante ore di volontariato si facciano in Italia. Queste sono tutte attività produttive che per la nostra economia sono importantissime, ma che nel PIL diventano invisibili. Per cui è importante trovare modi per valorizzare queste attività e tenere conto anche di queste attività nel sistema produttivo. A livello económico, ma anche in altri modi: non c’è una risposta specifica. Per esempio alcuni teorici della decrescita stanno elaborando proposte per un “reddito di cura”.
Anche la promozione di lavori più ecologicamente sostenibili è importante: possiamo decidere di eliminare una serie di lavori, ma possiamo anche decidere che di crearne degli altri. Secondo stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la transizione ecologica genererà milioni di posti di lavoro nel mondo, per esempio nelle rinnovabili. Puntiamo su quelli.
Possono innovazione e avanzamento tecnologico coesistere in un modello decrescetista?
Il discorso sulla tecnologia è un discorso che la decrescita non mette da parte. La decrescita non dice che è impossibile che la tecnologia ci salvi, ma che in questo momento non esistono tecnologie capaci di risolvere la crisi climatica. Di solito chi parla di cambiamenti climatici e di tecnologia porta sempre l’esempio dei BECCS (la cattura e sequestro di CO2 dalla biomassa) sostenendo che riusciremo a creare delle infrastrutture per catturare il carbonio. Le tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2 sono però sperimentali, e per ora non sono scalabili per sequestrare le quantità di carbonio necessarie.
Basare scenari di mitigazione del cambiamento climatico su tecnologie sperimentali mostra una sorta di fede cieca nella tecnologia. L’economia neoclassica ha sviluppato una serie di modelli di previsione che includono il fattore T, ovvero un fattore tecnologia che noi prevediamo venga sviluppato nel futuro con un certo ritmo e un certo impatto. Al netto della (dubbia) solidità di questi modelli, ci basta davvero questo, per puntare tutta la soluzione della crisi climatica sul “cavallo tecnologico”? Hickel fa un esempio nel suo libro: quando vogliamo affrontare un problema reale con una tecnologia che ancora non esiste, è come se ci buttassimo da un aereo senza paracadute dicendo che prima o poi il paracadute lo inventeremo. Lo fareste?
Non si tratta di avversione alla tecnologia: avremo bisogno di tutta l’innovazione tecnologica disponibile e avremo bisogno di finanziarla e di spingerla il più possibile. Per esempio, la transizione alle rinnovabili dobbiamo farla, perché le rinnovabili sono le tecnologie di conversione di energia più sostenibili che abbiamo in questo momento. Semplicemente non basta per mantenere invariato l’attuale modello economico. Non possiamo pensare di continuare a crescere senza cambiare la traiettoria, semplicemente cambiando la tecnologia di conversione energetica di riferimento.
Un’altra tematica spesso menzionata è quella di chi dice che dobbiamo fare decoupling tra crescita del PIL e utilizzo dei materiali. Sulla carta è un’idea bellissima, ma a livello empirico non ci sono prove che stia avvenendo in maniera significativa, come avete scritto anche voi. Alcuni casi di presunto decoupling a livello nazionale dipendono da come si fanno i calcoli: se inserisci la delocalizzazione della produzione, cioè il fatto che i materiali necessari vengono processati in un altro Paese, quel decoupling non esiste più perché il consumo di risorse è stato semplicemente contabilizzato da un’altra parte.
Alcuni sostengono che la crescita sia il vettore dell’innovazione, ovvero che senza crescita non sarebbe più innovazione? Qual è la posizione dei teorici della decrescita rispetto a questa idea ?
Nel nostro sistema l’innovazione è concettualmente legata alla crescita: dogmaticamente pensiamo che l’innovazione debba mirare a migliorare l’efficienza delle tecnologie per produrre di più. Ma l’innovazione è un’arma potentissima della specie umana: inventando e innovando miglioriamo il nostro ambiente e viviamo meglio. Semplicemente dobbiamo trovare un nuovo obiettivo per l’innovazione, oltre la crescita.
Un concetto spesso usato in questo senso è il discorso sulla convivialità del filosofo Ivan Illich. Già negli anni 70 Illich diceva che la nostra tecnologia stava iniziando a diventare pericolosa perché non la potevamo più controllare. Un principio che dovrebbe guidare l’innovazione e la creazione di nuove tecnologie è quello di creare strumenti che siano controllabili dalle persone e che rispondano ai nostri bisogni di base. All’interno del dibattito sulla decrescita si parla di innovazione conviviale, ovvero di quei processi di innovazione che non cercano il profitto ma il miglioramento delle condizioni di vita di persone e comunità. Intorno a questa necessità di reinventare l’innovazione è nato due anni fa un centro di ricerca chiamato post-growth innovation lab a Pontevedra, in Spagna, dove riflettono proprio su come possiamo ridisegnare l’innovazione e orientarla verso il benessere delle persone e la sostenibilità ambientale.
L’innovazione non va persa, ma dobbiamo superare il pensare comune per cui per all’innovazione serva la crescita. In realtà è il contrario: per la crescita serve innovazione. In questo momento l’innovazione è succube della crescita, ma come ci insegna tutta la caterva di brevetti di base che la nostra ricerca pubblica sforna ogni anno, possiamo innovare anche senza istituzioni orientate al profitto.