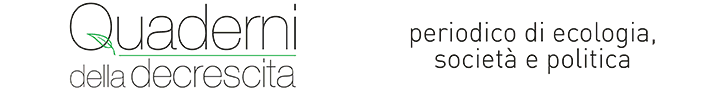di Marco Deriu, Associazione per la Decrescita
Mentre negli ultimi decenni si è molto parlato di crisi della politica e di crisi della democrazia, contestualmente nello stesso periodo si è registrata una rinnovata vitalità dei movimenti politici e sociali.
Si pensi alle più recenti espressioni del movimento femminista, da “Non una di meno” al “Me too”, che non soltanto hanno rimesso al centro la questione della libertà delle donne e della violenza maschile, ma che sono riuscite a modificare il senso stesso della giustizia e della vergogna sociale; si pensi poi al rinnovato slancio del movimento ecologista che, col mobilitarsi delle nuove generazioni – per esempio attraverso realtà come Fridays’ for future ed Extinction Rebellion – hanno costretto tutti, nel bene e nel male, a tornare a parlare di emergenza climatica, sostenibilità, transizione; fino al riscontro vasto e inaspettato delle “Sardine” che hanno contribuito ad arginare un clima politico di risentimento, odio, paura, soggezione e a rianimare una prospettiva politica differente. Ma si tratta solamente del riemergere di una corrente carsica che si è nutrita negli scorsi decenni di movimenti sindacali e operai, di movimenti pacifisti, antinuclearisti, per l’acqua pubblica ed i beni comuni, di movimenti contro le grandi opere e per la giustizia ambientale, di movimenti femministi e intersezionalisti, di lotte per il riconoscimento delle minoranze, di movimenti antirazzisti e per i diritti dei migranti, di movimenti antimafia e per la legalità, di movimenti animalisti e antispecisti, nonché di una folta messe di esperienze di economia solidale, di decrescita, di ricerca di forme di vita alternative nel mangiare, abitare, consumare, muoversi, lavorare ecc.
Eredità e limiti dei movimenti
Nella storia del nostro paese i movimenti politici e sociali hanno avuto a più riprese un ruolo determinante, non solo sul piano simbolico e della coscienza civile, ma anche in termini di risultati concreti e di incisività: hanno cambiato non solo il sentire comune, i costumi, la vita delle persone, ma anche i rapporti sociali, le leggi. Gli avanzamenti sul piano dei diritti dei lavoratori, dei diritti delle donne, delle leggi contro l’inquinamento e per la tutela della salute, del contrasto alle mafie e alla corruzione, sono stati spesso imposti nell’agenda istituzionale dalla pressione dei movimenti e della società civile. Insomma, occorre riconoscere che negli ultimi anni le occasioni di rinnovamento della società sono venute soprattutto dalle realtà di base, più che dai soggetti politici tradizionali, come i partiti o le istituzioni, che sono spesso stati indotti a recepire istanze provenienti dalla società civile.
In questo quadro positivo, occorre però riconoscere e fare i conti anche con i limiti di questi movimenti. Da questo punto di vista il pensiero torna al grande momento pacifista del 2003. Quando il governo statunitense di Bush decide di inventarsi una nuova guerra contro l’Iraq con giustificazioni fittizie, trascinando in quella disastrosa avventura gran parte dei paesi europei, la reazione fu globale, milioni di persone scesero nelle strade di tutto il mondo per manifestare il proprio “No alla guerra”. Manifestazioni pacifiste talmente imponenti da spingere il New York Times a parlare dell’esistenza di una «seconda superpotenza mondiale». In Italia l’orientamento pacifista, condiviso dal 75% della popolazione, si evidenziò con l’esposizione di bandiere per la pace fuori da balconi e finestre e con la grande manifestazione di Roma del 15 febbraio del 2003 che vide sfilare tre milioni di persone, la più grande manifestazione pubblica della storia italiana. Nella stessa giornata oltre 30 milioni di persone manifestarono in più di 800 città in tutto il mondo. Ma tutto questo non fu sufficiente a fermare la guerra e nemmeno a impedire realmente il coinvolgimento del nostro paese. Anche in questo senso il 2003 è uno spartiacque. È emerso come la “semplice” protesta dei movimenti, anche vasta, coordinata e diffusa, può non essere sufficiente ad un’affermazione di una volontà popolare democratica di fronte ad un sistema politico e istituzionale determinato ad andare in altre direzioni. Rimane dunque aperta una domanda sugli strumenti e sulla capacità “istituente” dei movimenti politici e sociali contemporanei.
La stessa questione rischia di riproporsi oggi su una partita ancora più importante, quella della crisi ecologica e climatica, e delle lotte per la giustizia economica e ambientale. Laddove la questione si spinge ancora di più verso il cuore dell’assetto istituzionale economico e politico vigente. Intendiamo qui la questione ecologica in senso integrale, riconoscendo in filigrana non solo i rapporti generazionali o di classe, ma anche il portato storico-sociale dei rapporti tra uomini e donne, dei rapporti (neo-)coloniali tra nord e sud globale e i rapporti tra gli esseri umani e le altre specie viventi.
A fronte di questa consapevolezza crescente, negli scorsi decenni molti e molte si sono spesi nella ricerca di stili di vita alternativi, in attività e progetti di associazioni, cooperative, circoli, librerie, Gas, mutue, botteghe, filiere, reti di accoglienza che hanno messo in campo e sperimentato concretamente una “moltitudine di buone pratiche”, nel relazionarsi, nell’abitare e nel coabitare, nel muoversi, nel produrre, nel consumare, in una logica di economia solidale e trasformativa, con gesti di cura e di responsabilità che dimostrassero la possibilità di un vivere differente e contemporaneamente prefigurassero la possibilità di un mondo diverso, anticipando i primi passi di un cambiamento collettivo. Senza negare o disconoscere nulla di questa enorme ricchezza sociale e politica, negli ultimi anni – in particolare tra gli amici e le amiche della decrescita – abbiamo iniziato a dirci che tutto questo, pur importante, non è più sufficiente di fronte: a) alla gravità della situazione, in ragione dei suoi effetti devastanti e di lungo periodo; b) all’ampiezza, alla profondità e alla portata del cambiamento richiesto e c) alla precarietà della finestra temporale che si staglia di fronte a noi.
Abbiamo iniziato a dubitare della capacità di queste pratiche e strumenti di «offrire soluzioni sistemiche alla crisi multidimensionale», di «avviare un vero processo di trasformazione, una via di uscita dal paradigma socioeconomico dominante del capitalismo di mercato, ecologicamente e socialmente insostenibile», come abbiamo scritto nella convocazione a questo incontro.
In questa fase siamo convinti che occorra insistere di più sul rischio che ciascuno rimanga nel proprio orto, e nella propria “buona pratica”, rinunciando a vedere il contesto più ampio e a porsi domande più radicali.
Soprattutto in un momento in cui ad una diffusa percezione del problema e a una crescente manifestazione di protesta non segue una risposta adeguata delle nostre istituzioni e dei nostri sistemi sociali ed economici. Da questo punto di vista il modo in cui la maggior parte dei movimenti ambientalisti e dei commentatori presentano la crisi climatica – “conosciamo il problema, abbiamo le soluzioni (tecniche, tecnologiche, economiche ecc.), manca solo la volontà politica di attuarle” – sottintende a nostro avviso una brutale semplificazione politica e sociale. Se qualcosa ci ha insegnato la psicoanalisi, è che possiamo essere perfettamente consapevoli delle nostre patologie (ossessioni, nevrosi, dipendenze, scissioni, depressioni…), eppure non essere realmente in grado di venirne fuori anche con tutta la buona volontà e le migliori intenzioni. Non è solo la nostra psiche ad essere complessa, e nemmeno solo il mondo biologico e i processi ambientali. Se aborriamo il riduzionismo scientifico e ambientale, dobbiamo evitare anche il riduzionismo politico e sociale. C’è a questo proposito un’enorme sottovalutazione delle differenze di interessi, sensibilità e aspirazioni, e conseguentemente delle diversità di analisi, di lettura e di prospettiva sociale-politica di fronte alla crisi attuale. E anche supponendo di avere individuato almeno alcuni obiettivi chiave, occorre ancora domandarsi: come costruire consenso? Come fare egemonia? Come rendere desiderabile o almeno accettabile quel cambiamento profondo di sistema che oggi a molti sembra ancora inaffrontabile, se non impossibile? Attraverso quali processi istituenti possiamo impiantare e radicare una trasformazione di questa portata?
L’aggravarsi della crisi e la necessità di riaprire gli spazi pubblici della politica
Il clima politico culturale in cui viviamo sembra di giorno in giorno sempre più cupo. Non solamente per il peggiorare della crisi ecologica e climatica (biodiversità, inquinamento, demografia, risorse, cibo, acqua), ma anche per la crescita delle diseguaglianze, il perdurare delle migrazioni forzate, la diffusione dell’intolleranza e della xenofobia, il riapparire dell’antisemitismo, e per concludere la diffusione di un machismo e maschilismo di ritorno, anche nell’establishment politico.
Può darsi che si debba toccare il fondo per provare a risalire, ma nel frattempo occorre constatare che la percezione crescente dei problemi e dei vicoli ciechi nei quali ci siamo infilati non sembra tradursi ottimisticamente in un apprendimento pedagogico, in una conversione o una catarsi collettiva. Da una parte infatti l’inazione delle istituzioni politiche contribuisce ad accrescere il senso di impotenza e angoscia dei cittadini anziché aiutarli ad affrontare problemi complessi come quelli climatici o quelli dell’immigrazione. Dall’altra il contrasto tra il peggioramento dei problemi e l’inerzia della politica produce un atteggiamento cinico verso la situazione che ostacola ulteriormente la ricerca di soluzioni alternative. Più in generale la caduta di fiducia nelle istituzioni democratiche rischia di lasciare sempre più spazio all’illusoria richiesta di uomini forti che hanno buon gioco a promettere di tirarci fuori dai guai, se solo deleghiamo loro il potere di prendere in mano la situazione.
In questo quadro, è fondamentale chiedersi dove possiamo trovare quella necessaria flessibilità che Gregory Bateson una volta ha definito come «potenziale non impegnato di cambiamento». Contrariamente a quanto siamo soliti pensare, spesso i luoghi apicali delle istituzioni non sono quelli più idonei a indirizzare e condurre il cambiamento. Spesso viceversa sono quelli più rigidi e resistenti al cambiamento, per il semplice fatto di essere i più intrecciati con altri centri di potere e quelli più esposti a interessi, pressioni, conflitti tra forze contrastanti. Anche per questo motivo è fondamentale lavorare con i movimenti, con le organizzazioni della società civile, per elaborare visioni e progetti, senza paura di dialogare con istituzioni, di fare pressione, di avanzare proposte, ma sempre a partire da una visione e da una prospettiva capace di autonomia e di conflitto.
Nel proporre un percorso di confronto politico, è necessario tuttavia evitare di percorrere strade già battute e logiche che si sono dimostrate fallimentari. Già diversi anni fa come Associazione per la decrescita abbiamo provato, con un documento intitolato “rigenerazioni”, a rivendicare le ragioni di uno spazio di soggettività e azione politica di tipo non elettorale. Probabilmente i tempi non erano ancora maturi. Nel frattempo, ci sono stati tanti tentativi di unire frammenti di tradizioni politiche, di assemblare cartelli elettorali, di portare movimenti nelle istituzioni. Ma scegliere la logica del confronto elettorale significa non solo finire con dedicare gran parte delle energie all’agone politico, ma anche entrare in una logica di competizione, di posizionamenti, in logiche e dinamiche che rischiano di essere faziose e divisive. Quello che stiamo proponendo non è dunque di creare un partito politico, e nemmeno una coalizione elettorale. Il nostro intento è invece di quello di rivendicare uno spazio di azione e progettualità politica dei movimenti, uno spazio autonomo rispetto ai partiti, e anche differente dal tradizionale terreno della competizione elettorale. Ampliare e rafforzare gli spazi sociali e politici di intervento, insistere sulle possibilità del lavoro dell’azione diretta non significa rinunciare al dialogo con le forze politiche e con le istituzioni, in particolari quelle locali, ma significa piuttosto gettare le basi per un confronto più maturo e stringente nella collaborazione come nel conflitto.
Nei fatti nel nostro paese i risultati più forti di trasformazione anche attraverso le istituzioni ci sono stati quando nell’ambiente attorno erano forti i movimenti (operaio, femminista, ambientalista ecc.), ovvero quando si è creata un’egemonia culturale, un’aspettativa sociale e si sono delineate delle richieste concrete. Quindi avere un buon rapporto con le istituzioni non vuol dire andare a supplicare o mendicare qualcosa, ma significa interloquire con la forza delle idee, delle proposte e di una più tenace consapevolezza. Senza dimenticare che le stesse istituzioni sono realtà storicamente e socialmente situate, che possono evolvere e cambiare a loro volta.
Da questo punto di vita è importante superare la paura della politica che blocca molti soggetti della società civile e molti movimenti. Certamente in questo agisce un timore di schiacciamento sulla logica dei partiti e delle fazioni, ma contemporaneamente si rivela anche un’immagine riduttiva della vita e dell’azione politica che viene identificata con il perimetro stesso delle istituzioni consolidate, ed in particolare delle istituzioni democratico-rappresentative. Ma come ci ha ricordato Hannah Arendt, l’azione politica «corrisponde alla condizione umana della pluralità, al fatto che gli uomini e non l’Uomo, vivono sulla terra e abitano il mondo». La politica riguarda dunque la convivenza e la comunanza tra diversi. Oggi lentamente iniziamo a pensare che la politica riguardi perfino un’idea di pluralità e di relazione più ampia che comprende popoli, generi, generazioni, specie differenti. Occorre ampliare il perimetro di ciò che intendiamo come spazio della politica, come spazio di confronto e azione collettiva e plurale dei movimenti, passando dalla protesta al progetto.
Dalla protesta alla co-progettazione
Ma lavorare assieme, lo sappiamo, non è così semplice. Come confrontarsi tra soggetti e movimenti diversi?
Dobbiamo intanto evitare gli inciampi più consueti. In primo luogo occorre rinunciare a pensare che la cosa di cui ciascuno si occupa sia la più importante: non perché si supponga che tutto sia sullo stesso piano e non ci siano cose particolarmente cruciali e rilevanti, ma perché le cose più importanti sono inevitabilmente incorporate e connesse ad altre questioni e non si può affrontare un problema senza contemporaneamente tirare e riconoscere i fili che lo legano ad altri problemi. Lavoro, cura, ambiente, salute, giustizia sociale, rapporti tra i sessi: chi oggi pensa realmente che si possa affrontare uno solo di questi temi chiudendo gli occhi o mettendo tra parentesi gli altri?
In secondo luogo, occorre superare l’ingenua logica della sommatoria: 1+1+1 (questo movimento più quello più quell’altro, un po’ di sostenibilità, un po’ di diritti delle donne, un po’ di solidarietà agli immigrati ecc.), lasciando ciascuno uguale a se stesso, in una comune solitudine. Occorre per questo puntare sulla curiosità e sul desiderio di lasciarsi contaminare gli uni dalle altre.
Non è utile nemmeno tentare di ritagliare quello che abbiamo in comune tra storie, movimenti, culture, saperi differenti. Se ragioniamo solo a partire da quello che abbiamo in comune e nient’altro, alla fine rimane ben poco di situato e significativo. Perché quello che possiamo portare di più interessante è proprio ciò che ci rende peculiari e diversi nella nostra esperienza e sensibilità dagli altri. Come ho scritto altrove dobbiamo ragionare non nella logica riduttiva del massimo comune divisore ma in una prospettiva di moltiplicazione, ovvero in quello che in matematica si chiama il “minimo comune multiplo”. Dobbiamo ragionare attorno a una visione e un progetto che trascende e al tempo stesso ricomprende ciascun singolo soggetto e che è molto di più della somma delle parti. Praticamente significa non limitarsi a ricercare nell’altro ciò che conosciamo già, ma piuttosto ciò che ci manca e che potrebbe – grazie a questo altro – divenire più familiare anche a noi stessi. Significa entrare nella logica di un insieme più vasto, in cui ciascuna realtà viene inclusa e allo stesso tempo superata da una visione più grande che comprende tutti e allo stesso tempo amplia le identità di ciascuno.
Il lavoro che vogliamo proporre è dunque quella di dar vita nell’anno a venire ad un percorso di confronto, discussione e co-progettazione tra movimenti che culmini nella costruzione di una piattaforma comune di impegni, proposte, campagne, che nasca dal basso e che raccolga la sfida di un cambiamento necessario, urgente, desiderabile. Non si tratta però solo di una sintesi teorica (per quanto utile possa essere) e nemmeno del raggiungimento di un comune sentire, ma piuttosto dello sforzo di creare spazi comuni di confronto, di far incontrare storie ed esistenze, di sperimentare prassi differenti, di mettersi in gioco fra diversi e diverse, provando davvero non solo a condividere, ma a pensare assieme, a co-immaginare e co-progettare un futuro diverso.