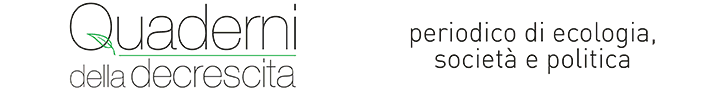Produrre come e per chi. La crisi strutturale e di senso della civiltà contemporanea impone un ripensamento altrettanto profondo dei modi e degli scopi della cooperazione sociale: cosa, quanto, come, dove produrre e a beneficio di chi.
Conversazione con Paolo Cacciari (Treviso Biblioteca comunale, Ciclo di incontri Pensare il cambiameto)
Le domande cruciali che da sempre si sono poste le “scienze economiche” sono: cosa produrre, come, quanto, dove, per chi? Proviamo a dare un ordine coerente a questi quesiti. Ma per riuscire a farlo, dobbiamo porci una domanda preliminare: perché produrre?
Vi è poi una meta-domanda che sovrasta tutte le altre (a cui proverò a rispondere alla fine): chi è abilitato a dare le risposte a tutte queste domande? Ovvero: chi ha l’autorità e il potere di stabilire e decidere con quali modalità produrre, in quali quantità e località, a beneficio di chi ecc. ecc.?
Iniziamo.
1.
Perché produrre? Perché lavorare? La risposta è facile, persino banale. Gli esseri umani si attivano per produrre strumenti, oggetti, sistemi organizzativi utili a rispondere a dei loro bisogni e a delle loro esigenze. Quali: soddisfare le necessità primordiali della sussistenza e della sicurezza personale, aumentare le comodità e diminuire le fatiche, dare risposte alle curiosità di conoscenza dei misteri del mondo ed anche cercare di soddisfare i desideri più fantastici.
Quindi, ci si dà da fare, si opera e si lavora per fare cose utili a se stessi e agli altri. Il lavoro per essere un “buon lavoro” deve soddisfare chi lo compie. Deve far emergere il proprio saper fare, mettere alla prova le proprie attitudini. Allo stesso tempo il lavoro deve essere “vero”, cioè deve produrre concrete utilità. Persino quello meno utilitaristico che si possa immaginare, cioè il lavoro dell’artista, è un atto espressivo che ambisce ad entrare in relazione emozionale con gli spettatori. Il lavoro, al fondo, è sempre un atto di donazione del proprio tempo e delle proprie capacità a favore di chi ne usufruisce. Altrimenti è un solo un passatempo, un impiego per sfaccendati. Ha scritto Claudio Napoleoni: “Il lavoro non è positivo che a una condizione, cioè che i prodotti siano contemplati e riconosciuti come buoni” (in Pallante, 2016).
In questo modo vi sarete accorti che ho posto, indirettamente e conseguentemente, dei criteri utili a rispondere anche alla domanda di come bisogna produrre e di cosa produrre. Bisogna produrre con modalità che favoriscano la esplicitazione dell’intelligenza e della creatività degli individui che si applicano a quel lavoro. Potremmo così affermare che il primo diritto del lavoratore è poter scegliere cosa più gli piace fare. Tutti i lavori che invece svalorizzano chi li compie, che depotenziano i loro personali bagagli psicoattitudinali, che comprimono le loro prestazioni in un mansionario predeterminato e fuori dal loro controllo, che riducono il lavoratore ad un prestatore d’opera robotizzato… sono forme di produzione da condannare, disumanizzanti e alienanti.
Allo stesso modo sono riuscito a rispondere anche alla domanda di cosa produrre. Bisogna produrre cose che siano beni, cioè, oggetti, strumenti, sistemi organizzativi che aumentino il benessere delle persone e delle comunità.
2.
Ci rimangono i quesiti: quanto, dove, quando produrre. Mentre lasceremo per ultima la domanda per chi produrre.
Il lavoro produttivo è sempre una attività di prelievo e trasformazione di materie che si trovano in natura. Lo diceva anche Karl Marx (che pure ha fondato la sua teoria del valore di scambio sul potere del capitale): “La natura è la fonte di ogni valore d’uso e di essa è fatta la ricchezza reale”. Prima di lui, uno dei primi economisti, William Petty (1623-1687) scriveva: “il lavoro è il padre della ricchezza mentre le terre sono la madre”. Chiamateli come volete (terra, capitale naturale, flussi di materia e di energia, materie prime, risorse naturali, ecosistem services…) si tratta sempre di doni della natura, dell’ecosfera, di Madre Natura, del Creato, di Gaia, di Pacha Mama… E la Terra è per definizione limitata, circoscritta, finita.E’ un sistema chiuso per materia e aperto all’energia che riceve dal Sole. Le risorse materiali, gli ettari a disposizione procapite, quindi, si riducono per un effetto a tenaglia: da una parte, l’aumento della popolazione e, dall’altra, la degradazione della funzionalità degli ecosistemi determinata dal rilascio di sostanze inquinanti dai processi produttivi e di consumo, dall’eccesso di prelievi e, in generale, dall’aumento della pressione antropica.
http://www.lowcarboneconomy.com/community_content/_pictures/1993
Fig.2
Global resource extraction by material category 1980-2011. Da: www.materialflows.net
In this figure, global resource extraction (including only used materials) between 1980 and 2011 is presented. Four material categories are separately shown: metal ores, industrial and construction minerals, fossil fuels and biomass (from agriculture, forestry and fishery).
Da notare che il “consumo di natura”, calcolato con le tabelle del Phisical imput-output (anche l’Istat sta incominciando ad elaborarle) che rivela i consumi mondiali di materie prime, cresce paurosamente smentendo le previsioni di quanti ritenevano che le nuove tecnologie, aumentando l’efficienza dei sistemi produttivi (meno sprechi, più ricicli ecc.), avrebbero “dematerializzato” l’economia, miniaturizzato apparecchi e macchinari vari e che, in particolare, le tecnologie elettroniche applicate alla telecomunicazione avrebbero ridotto l’uso della carta e il bisogno di spostare merci e viaggiatori. Nella realtà, si è verificato il contrario per effetto del noto paradosso (effetto Rebulding o altrimenti detto “illusione tecnologica”) illustrato già da William S. Jevons nel lontano 1865: “La resa maggiore delle caldaie a vapore fa aumentare la loro utilità, quindi la loro diffusione e i consumi totali di carbone”. Ed è così per ogni cosa: se uso l’automobile di nuova generazione per aumentare i miei spostamenti motorizzati, annullerò i benefici del risparmio di carburante. Se mai è vero che le nuove marmitte catalitiche riducono l’immissione di polveri sottili é sicuramente vero che l’aumento esponenziale delle automobili in circolazione nel mondo peggiora il bilancio complessivo dell’inquinamento. Ricordo solo che per produrre un computer servono 15.000 kg di acqua, 250 kg di petrolio, 22 kg di sostanze chimiche. Nel mondo ogni anno vengono venduti 150 milioni di computer, mentre vengono prodotti 50 milioni di tonnellate di RAEE (rifiuti elettronici). Un computer d’uso domestico viene dismesso ogni 3-4 anni ed uno ad uso aziendale ogni 12-18 mesi. Solo il 20% viene riciclato.
In definitiva il Total Material Requirement (il fabbisogno di materiali pro-capite) non fa che aumentare. Secondo dei dati pubblicati da Giorgio Nebbia, un cittadino americano “consuma” 85 tonnellate all’anno di materiali vari, un tedesco 74, un europeo medio 51, un giapponese 45. Un altro studio commentato da Gianfranco Bologna (www.materialflows.net) ci dice che dal 1980 al 2008 il consumo mondiale di materie prime (risorse biotiche, quali biomasse da agricoltura, foreste, pesca, e materiali abiotici, minerali e metalli) è aumentato dell’80% (da 38 a 68 miliardi di tonnellate all’anno). Sono cifre enormi che stanno comportando danni irreversibili e irreparabili al pianeta. Tutti questi materiali prelevati dalla natura ce li ritroviamo prima o poi, dopo cicli di utilizzazione più o meno lunghi (life cycle materials) sotto forma di scarti, residui, rifiuti.
Gli scienziati hanno individuato nove principali emergenze planetarie, che sono: l’acidificazione degli oceani, l’utilizzo dell’acqua dolce, la riduzione della fascia di ozono nella stratosfera, l’utilizzo del suolo fertile, il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il ciclo bio-geo-chimico dell’azoto e del fosforo, l’aereosol atmosferico, gli inquinanti chimici (vedi il Planetary Boundariesdi di Johan Rockstrom).
Da una trentina d’anni (con la pubblicazione del rapporto Bruntland, Our Common Future, del 1987 della Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo, WCED) il lemma “sviluppo sostenibile” è diventato d’uso comune. L’idea che ci sta sotto è il decoupling: la possibilità di disaccoppiare crescita economica e pressione antropica sugli ecosistemi. Un’equazione che assomiglia a quella della capra e del cavolo da trasportare in barca e che nessun modello economico sembra ancora essere riuscito a risolvere.
Se tutto ciò non è solo una trovata per il marketing delle “green technology”, allora il primo senso pratico della sfida della sostenibilità dovrebbe essere quello della riduzione netta del consumo di natura dentro i limiti della capacità di rigenerazione dei cicli bio-geo-chimici dell’ecosistema planetario. Solo così si preservano le condizioni di abitabilità del pianeta e di sopravvivenza delle generazioni future.
E con questo abbiamo risposto anche alla domanda di “quanto produrre”: non si deve prelevare più di quanto la Terra non sia capace di metabolizzare, rigenerare, restituire.
3.
La questione della sostenibilità non è solo quantitativa. Non si misura solo in tonnellate e non riguarda solo i bilanci di materia ed energetici. Come ci ricorda sempre Giorgio Nebbia: “L’ineguale distribuzione geografica delle materie prime è alla base di conflitti per conquistare o controllare le risorse agricole, le foreste, i minerali e le fonti di energia” (Nebbia, 1998). C’è da rimanere allibiti, quando, ad esempio, nei consessi politici intergovernativi (ad esempio le Conferenze delle parti sul cambiamento climatico) gli esperti attribuiscono ai paesi produttori asiatici la responsabilità di emettere quote di gas inquinanti che vengono generate per produrre merci che poi vengono comprate e usate dalle popolazioni più ricche nei i paesi più ricchi. Siamo in presenza di nuove forme di colonialismo ipocrita che vengono attuate attraverso la delocalizzazione di attività industriali obsolete e inquinanti, l’acquisto di terreni fertili (e della relativa acqua incorporata) per ricavarne prodotti alimentari da esportazione (land grabbing), lo smaltimento nei paesi più poveri di rifiuti tossici e pericolosi provenienti dagli Stati Uniti e dall’Europa (waste dumping), la sottrazione di minerali e metalli rari dai giacimenti dei paesi poveri.
Solo per citare la vicenda più macroscopica voglio ricordare che le guerre in corso in Congo per l’accaparramento del coltan ha provocato 5 milioni di morti. Le apparecchiature elettroniche che comunemente usiamo (ma anche dispositivi militari e armamenti) non hanno bisogno solo di ferro, plastica e silicio, ma di minerali rari come il tungsteno, il tantalio e il niobio (coltan), il vanadio, il berilio, il platino, l’oro… Sulle “terre rare” si sta giocando una buona parte della guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa, da una parte, e Cina dall’altra.
La questione della sovranità sull’uso delle risorse naturali è quindi centrale per stabilire non solo quanto produrre, ma anche dove localizzare le produzioni dei beni di consumo. Le “ragioni di scambio” tra produttori e consumatori – in una economia di mercato, come vedremo più avanti – sono sempre squilibrate a favore di chi è economicamente più forte e in grado di imporre sistemi produttivi a lui più convenienti. La asimmetria del potere fondato sul denaro provoca disparità e diseguaglianze di valore attribuito ai vari impieghi di manodopera e di materiali. Il valore sul “libero mercato” di un quintale di caffè non consentirà mai ai suoi produttori ad eguagliare il prezzo di mercato di un computer o di un’altra qualsiasi mercanzia prodotta nei paesi che detengono tecnologie e capitali, brevetti e titoli di proprietà. Si generano così divisioni di tipologie di lavoro e stratificazioni di classi sociali tra le varie aree geografiche del mondo a al loro interno. Banalmente, un’ora di lavoro non ha lo stesso prezzo per diverse prestazioni e diversi territori. La globalizzazione dei mercati e dei capitali a fronte della inevitabile fissità territoriale delle popolazioni (a meno di non doverle costringere a migrazioni bibliche) provoca disparità e disuguaglianze. Chi ha già riesce ad ottenere sempre di più, chi ha meno si impoverisce. Gli studi sulle disuguaglianze sono oramai molto vasti. Economisti come Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Luciano Gambino sono diventati autori molto popolati.
Fig.n.3
La concentrazione della ricchezza globale secondo i dati Oxfam
Questa tendenza alla diseguaglianza può essere contrastata solo con un processo di ri-territorializzazione delle produzioni (de-globalizzazione), da una parte, e di introduzione di clausole sociali e ambientali negli scambi internazionali, dall’altra. Sarebbe necessario rendere le diverse aree geografiche del pianeta (bioregioni) e, al loro interno, le comunità locali, sempre più autosufficienti e autonome, meno dipendenti da poteri che agiscono fuori dal loro controllo, così l’umanità intera potrebbe imparare a utilizzare al meglio le risorse disponibili senza essere costrette ad andare a prenderle altrove (con le buone o con le cattive, con i denari o con gli eserciti). Bisognerebbe immaginare i rapporti commerciali internazionali impostati sulla base di una effettiva reciproca, paritaria utilità.
4.
Rimane ora la domanda: per chi produrre? La risposta è: per tutti coloro che hanno il bisogno di ottenere beni e servizi utili al loro benessere. E’ questa una risposta semplice, apparentemente oggettiva e neutra che però nasconde difficili implicazioni e molte trappole. Vediamone alcune.
Innumerevoli studi di antropologia e psicologia sociale (oltre alle evidenze che ognuno di noi può riscontrare nella vita di tutti i giorni) ci dicono che le esigenze delle persone non solo mutano nel tempo, nei luoghi e nelle culture in cui sono inseriti, ma sono sempre socialmente determinate. Tutti i tentativi di catalogare e gerarchizzare i bisogni secondo un ordine raziocinante predefinito (beni necessari, beni fondamentali, beni di largo consumo, beni superflui, beni voluttuari, beni di lusso ecc.) sono naufragati di fronte ai comportamenti “irrazionali” delle persone che sono spesso determinati da convenzioni e convinzioni preconcette che travalicano la logica teorica prescritta delle “scienze economiche”; il famoso tipo umano ideale – l’homo oeconomicus – che compra le cose che più gli servono al prezzo minore. Ad esempio, negli anni della crisi economica è diminuito il consumo di generi alimentari, ma non quello dei telefonini. Vuol dire che l’esigenza di mantenere buone comunicazioni sociali era maggiore di quella di una buona alimentazione. Persino papa Bergoglio pensa che la voce di Dio arrivi ai giovani tramite le onde elettromagnetiche degli smartphone! Nei paesi dell’ex Unione Sovietica, dopo il crollo, l’età media della vita si è ridotta drasticamente. Segno che le popolazioni tenevano di più alla libertà che alla propria salute, alla piena occupazione e all’appartamento di edilizia popolare. E ancora; é esperienza quotidiana constatare che le persone sono più attente al lato estetico delle cose che comprano che non, ad esempio, alla loro durevolezza e praticità. Avete mai provato a camminare su una scarpa con il tacco a spillo?
Schiere di psicologi ci dicono che i nostri stili di vita sono dettati da processi di imitazione, di ricerca di riconoscimento sociale attraverso lo status e l’esibizione di beni posizionali. La nostra psiche è debole. Siamo invidiosi e temiamo il giudizio degli altri più di ogni altra cosa, perché abbiamo paura dell’isolamento, della perdita delle reti di relazioni umane, della solitudine.
Gli addetti al marketing delle imprese sanno molto bene tutto questo. Un loro famoso motto è: “Non vendiamo cose, ma sogni”. Il presupposto fondamentale su cui si basa l’economia di mercato è che i desideri delle persone siano infiniti. Lo definì perfettamente già Thomas Hobbes (Leviatano 1651) agli albori del capitalismo: “La felicità è un continuo progredire del desiderio da un oggetto all’altro non essendo il conseguimento del primo che la via verso il seguente”. Da qui la amara considerazione di Bauman: “La società dei consumi si fonda sull’insoddisfazione permanente cioè sull’infelicità” (Bauman 2007). E la conclusione lapidaria dell’economista critico Bernard Maris: “Il capitalismo organizza la scarsità, i bisogni e la loro frustrazione” (Maris 2002).
In quest’ottica scopriamo che il sistema economico esistente non è affatto finalizzato a produrre cose necessarie al minor prezzo possibile per renderle accessibili a chi ne ha più bisogno (e meno disponibilità economiche) – come si vorrebbe far credere -, ma alla produzione di beni e servizi volti a soddisfare il numero sempre crescente dei bisogni di quei consumatori che hanno le maggiori possibilità di solvibilità sul mercato. Il sistema capitalistico non si propone di produrre per soddisfare le necessità fondamentali, ma per aggiungere sempre nuovi bisogni da soddisfare. Ha scritto Nicolas Ridoux: “voler creare un numero illimitato di bisogni per dovere poi soddisfarlo è come inseguire il vento” (Ridoux 2008).Un inseguimento che non finisce mai.
Qui sta l’errore di Keynes (ma anche dei marxisti che, da socialisti o comunisti, si sono trovati a dover governare l’economia) che pensava fosse possibile usare a fin di bene e transitoriamente il sistema di produzione fondato sull’accumulo del capitale. Prima l’abbondanza (da raggiungere con i cattivi mezzi del capitalismo) poi la giustizia che ci proietterà nel regno delle libertà.
E’ noto che lord Keynes pensava che nel giro di pochi anni (scriveva nel 1930) i suoi nipoti avrebbero avuto vitto, alloggio, vestiario, salute e istruzione con poco sforzo (sarebbero bastate tre ore al giorno di lavoro per produrre tutto questo) grazie, appunto, agli straordinari sviluppi delle tecnologie e della produttività del lavoro. Così si sarebbe risolto il problema della “scarsità” che è la ragione stessa dell’esistenza delle “scienze economiche”. Non solo i suoi nipoti, ma anche gli economisti avrebbero, quindi, potuto dedicarsi a lavori più creativi. Ma, scrive Keynes, c’è un prima, un frattempo: “almeno per i prossimi 100 anni dobbiamo pretendere da noi stessi e da chiunque altro che il brutto è il bello e il bello è brutto, perché il brutto è utile, mentre il bello non lo è. Ancora per qualche tempo l’avarizia, l’usura e le misure protettive devono essere i nostri dei. Perché solo loro possono condurci fuori dal tunnel della necessità economica”. Come scrivono gli Skidelsky, padre economista e figlio filosofo (E e R. Skidelsky 2013), le ragioni del fallimento della profezia di Keynes (piena occupazione e riduzione dell’orario del lavoro) non è dipeso da un errore di valutazione sull’aumento della capacità produttiva del sistema capitalistico e nemmeno dalla ricchezza monetaria in circolazione – anzi ! -, ma nell’aver sottovalutato la logica di funzionamento del sistema economico capitalistico che si fonda sull’accrescimento indefinito e perpetuo della produzione. E’ pericoloso andare a patti con il diavolo! Nel prometterti tutto quello di cui hai necessità altera la percezione dei bisogni rendendoti insaziabile. Già Epicuro aveva detto: “Niente è sufficiente a colui che il sufficiente non basta”.
Tutto ciò allontana in definitivamente la meta della “soluzione del problema economico della scarsità”, rende impossibile il raggiungimento del soddisfacimento delle proprie necessità e condanna le persone a vivere in un perenne stato di necessità. L’era dell’abbondanza viene in continuazione posticipata. Le risorse (naturali, di conoscenza, tecnologiche, finanziarie…) ci sarebbero, ma la logica che presiede il suo utilizzo in una società dominata dalle ragioni mercantili non consente che vengano impiegate con criteri di equità e sostenibilità. Al contrario genera in continuazione scarsità ed esclusione. Una spirale che allarga le distanze tra il vertice degli individui insaziabili e la base degli affamati. Una spirale che trascina l’umanità nella dissipazione insensata delle risorse naturali. Un sistema sociale irrazionale e ingiusto. Che alla lunga non regge né sul piano del banale calcolo utilitaristico tra costi e benefici, né su quello dell’etica, della ricerca del bene comune e condiviso.
Le risorse sono limiate, ma non “scarse”. La scarsità è sempre relativa. É generata da chi ne fa un uso eccessivo (a beneficio esclusivo), sottraendo risorse ad altri e ingenerando desideri di acquisizione in chi ne è escluso. Se tutte le risorse venissero rese accessibili a tutti, basterebbero necessariamente a soddisfare i bisogni di ciascuno. Ognono si farebbe bastare ciò che ha a disposizione. L’economia di mercato e il diritto di proprietà sono le tecniche con cui si rendere conveniente (in termini monetari) ed esclusivo (stabilendo titoli di proprietà) l’uso delle risorse a favore di pochi.
Ha scritto Gandhi: “La civiltà nel vero senso della parola, non consiste nel moltiplicare i bisogni, ma nel limitarli volontariamente”. Ogni individuo si dovrebbe limitare a possedere, usare e consumare solo quelle cose che anche tutti gli altri esseri umani possono permettersi.
Il problema, quindi, non è produrre sempre di più, ma al contrario trovare il modo di contenere, ridurre i nostri infiniti desideri di possesso e dissipazione.
Meglio allora sarebbe cambiare la visione delle cose. Smetterla di pensare al pianeta Terra come ad una matrigna avara (contro cui imprecare e cercare di ottenere sempre di più) e pensarlo invece come una madre nutrice, benefica, i cui doni sono benedizioni (Illich), da rispettare nei suoi limiti e venerare per la sua generosità.
Fuori da metafora dovremmo cambiare la teoria economica fondamentale che si basa sul principio di scarsità e sostituirlo con quello del limite. L’assunzione delle condizioni biofisiche di funzionamento del pianeta come vincoli inviolabili (ecocentrismo) ci devono condurre alla ricerca del bastevole e della sufficienza. Cioè della condivisione.
La coniugazione di equità (giustizia distributiva) e libertà (autonomia di scelte) che la cultura politica occidentale non è mai riuscita a realizzare potrebbe invece essere possibile inanellando altri due concetti: sostenibilità e condivisione. Riconoscimento dei limiti delle risorse a disposizione dell’umanità e loro equa messa in comune. Nessun individuo può essere escluso dal beneficiare dei doni della natura. Tutti devono essere responsabili del loro uso.
5.
Veniamo finalmente alla meta-domanda che mi ero posto all’inizio: chi ha il potere di decidere cosa produrre, per chi, dove, quanto ecc. ecc.?
Come noto, grosso modo, due scuole di pensiero e d’azione si sono confrontate nella storia contemporanea. Ma nessuna delle due ha funzionato in modo soddisfacente.
Il liberismo e il socialismo (con tutte le gradualità e le reciproche contaminazioni immaginabili e possibili: tra cui “l’economia sociale di mercato”, che vorrebbe moderare i due sistemi, e il “capital-comunismo” della Cina che invece esaspera il peggio dei due sistemi). Gli uni pensano che il gioco dei liberi mercati sia in grado di trovare l’equilibrio dinamico tra la domanda e l’offerta di beni e servizi tale da soddisfare le esigenze di ogni individuo (lavoro in cambio di consumi). Gli altri pensano invece che tale equilibrio (piena occupazione e soddisfacimento delle necessità essenziali) possa realizzarsi solo attraverso una procedimento (più o meno democratico, più o meno partecipato politicamente) di pianificazione (più o meno centralizzata, più o meno decentralizzata).
Tra i primi troviamo i tecnocrati della espertocrazia come Mario Draghi, che pensa che la cosa migliore sia affidare l’economia ad un “pilota automatico” (programmato dalle autorità monetarie, ovviamente!). Tra i secondi ci sono i professionisti della politica che credono in una capacità del sistema dei partiti di svolgere una funzione super partes al servizio dell’interesse generale.
Le differenze tra i due sistemi non sono di poco conto, ma non nella cosa essenziale: tutti e due i modelli e tutte le esperienze storiche che si sono fin qui verificate ritengono che lo scopo essenziale della cooperazione sociale tra le persone debba essere quello di accrescere in definitivamente la produzione di beni e servizi. Le differenze sono sulle modalità, non sull’obiettivo. I primi pensano che lo sforzo delle istituzioni debba essere quello di far funzionare nel modo più libero e automatico possibile la “mano invisibile” che regola il bilanciamento della domanda e dell’offerta. I secondi pensano che “gli spiriti animali” assetati di ricchezza che muovono le attività produttive debbano essere contenuti e guidati da mani forti e ben visibili delle istituzioni pubbliche dello stato.
Ma tutti e due pensano che si debba aumentare all’infinito l’efficienza, il rendimento, la convenienza, l’utilità del sistema economico produttivo. La partita doppia (il calcolo dei costi e dei ricavi, del dare e dell’avere) è la forma mentis e il modus operandi che domina gli agenti tanto delle imprese quanto delle istituzioni pubbliche. Le altre cose che danno un senso alla vita (il giusto, il bene, il bello; ovvero: la qualità delle relazioni umane che si instaurano tra le persone, la solidarietà, l’aiuto reciproco, l’affettività, l’altruismo…) sono messe in secondo, terzo, quarto piano. Salvo poi, quando scoppia una crisi economica imprevista, sentirci dire che alla base di tutto ci sono “fattori esterni irrazionali” (che ovviamente non dipendono dagli economisti) che fanno cadere la “fiducia” degli operatori economici, provocano “panico” nei risparmiatori, “impigriscono” i giovani e così via psicoanalizzando il disagio sociale.
Alain Caillé ha detto che la società è stata ridotta ad “una orribile macchina per produrre”. L’economia è un procedimento che ha a disposizione una strumentazione (il denaro, le tecnologie ecc.) e un dispositivo giuridico (le leggi, le istituzioni ecc.) che servono a ridurre ogni cosa reale (res) ad un valore monetario astratto (pecunia). Dai beni alle merci. Economia e denaro sono diventati la stessa cosa. L’economia si è ridotta ad occuparsi del denaro (da dove viene generato, come gira e come rigira…) e induce a pensare che con il denaro si possa ottenere ogni cosa. Il potere del denaro è diventato assoluto, supera ogni altro potere.
Bisogna allora pensare di cambiare in radice il modo di pensare l’economia (oikos-nomos, le buone regole della dimora, che oggi è diventata il mondo intero) e inserirla nel sistema etico. Ripensare l’economia come una scienza morale. Quantomeno sarebbe opportuno relativizzarla, metterla in relazione con le altre dimensioni del vivere umano.
Chi può compiere questa rivoluzione culturale? Castoriadis diceva che servirebbe una “rottura dell’ordine simbolico e fattuale”. Non c’è scampo, non c’è scorciatoia. Il soggetto del cambiamento siamo ognuno di noi. Sono le convinzioni morali profonde delle persone che devono spingerci a comportamenti individuali responsabili e solidali, a trovare forme sempre più diffuse, pervasive, decentrate di comunità capaci di autosostenersi e di autogovernarsi. Bisognerebbe avere in testa un’idea di individuo, di comunità locali e di istituzioni sociali organizzate sui principi dell’eco-municipalismo.
Transitare da comportamenti ispirati alla competizione e alla rivalità ad altri fondati sulla condivisione e sulla reciprocità; dal dominio sui processi naturali alla loro cura; dall’egoismo alla solidarietà sociale cooperante e alla messa in comune delle ricchezze prodotte socialmente; dall’eccesso alla sobrietà; dal riduzionismo pseudo scientifico dei “saperi esatti”, alla complessità dei sistemi trans-disciplinari e olistici; dall’economia del massimo rendimento ad una del massimo risparmio, del riutilizzo, del riciclo; da un’economia dei soldi, del consumo e del debito alla bio-economia e al buon vivere. La felicità è una buona relazione con l’ambiente e gli altri esseri umani.
Zigmunt Bauman, Voglia di comunità, Laterza 2007
Paolo Cacciari, Vie di fuga, Marotta & Cafiero 2014
Ivan Illich, Bisogni, in Dizionario dello sviluppo, Edizioni Gruppo Abele 1998
Tim Jakson, Prosperità senza crescita, Edizioni Ambiente 2011
Roberto Mancini, Ripensare la sostenibilità, Franco Angeli, 2015
Bernard Maris, Antimanuale di economia, Marco Tropea2003
Giorgio Nebbia, La violenza delle merci, www.fondazionemicheletti.it, 1998
Maurizio Pallante, Destra e sinistra addio. Per una declinazione dell’uguaglianza, 2016
Nicolas Ridoux , La decrescita per tutti, Jaca Book 2008
E. e R. Skidelsky, Quanto è abbastanza, Mondadori, 2013