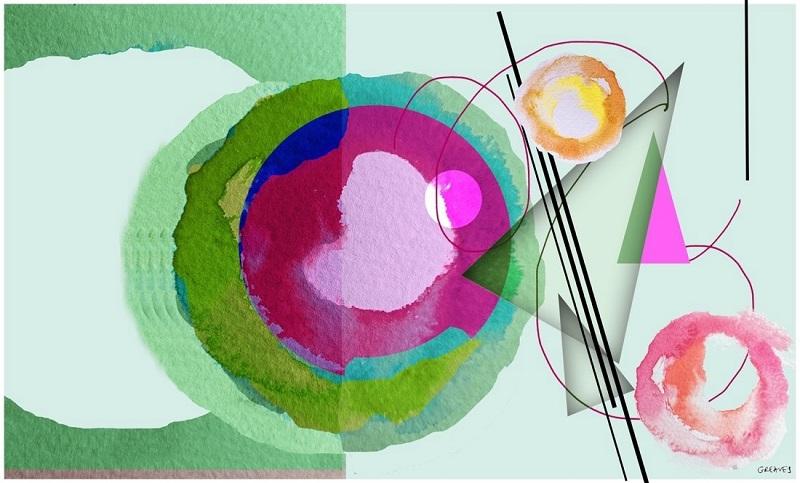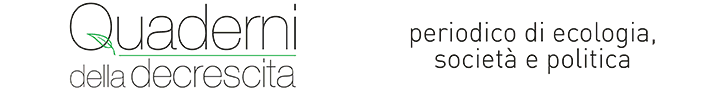La recente mostra Riccardo Dalisi. Radicalmente, a cura di Gabriele Neri negli spazi del Maxxi di Roma, ci offre l’occasione per affrontare un aspetto un po’ trascurato eppure significativo della singolare e ricchissima produzione di Riccardo Dalisi, ovvero quella prossimità al pensiero decrescente di cui un accenno si intravede già nei primi anni Settanta, ma che si sviluppa poi più apertamente in temi, forme e modi degli anni Duemila. Figura poliedrica e originale, Dalisi (classe 1931) è stato architetto e designer di grande spessore, capace di affrontare le grandi questioni dell’architettura lavorando concretamente sul campo, accogliendo le sollecitazioni e le opportunità di crescita umana e creativa offerte dall’immersione in contesti sociali marginali, emarginati eppure autentici, per poi rielaborare e condividere il suo pensiero sulle pagine di riviste specialistiche. Non siamo però di fronte ad un outsider, anzi, il nostro si è affermato nel circuito ufficiale come stimato progettista: due volte vincitore del Compasso d’oro – il secondo nel 2014 per l’impegno nel sociale –, è stato a lungo titolare della cattedra di Progettazione architettonica alla Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli.
Cominciamo dalla fine, dagli anni 2000, quando il suo lungo percorso polimorfo, articolato tra architettura, design, ricerca, pedagogia e arte, si condensa infine in una poetica ch’egli stesso definisce decrescente. Così testimoniano il volume “Decrescita. Architettura della nuova innocenza” edito da Corraini nel 2009 e due mostre, la prima dello stesso anno Riccardo Dalisi. Il Teatro della Decrescita: Architettura e Design della nuova Innocenza alla Casa dell’Architettura di Roma (curata da Alfio Cangiani), la seconda dal titolo Riccardo Dalisi: la sfida della nuova innocenza – Per una creatività lungo la via della decrescita ospitata nel 2012 al Museo Luzzati di Genova.
Gli spazi espositivi concepiti da Dalisi si animano ogni volta di disegni, dipinti, piccoli e grandi oggetti in cartapesta, installazioni mobili, grandi sculture in ferro o rame, presenze buffe e giocose intrise delle suggestioni della storia dell’arte. Tutte creazioni realizzate con semplici materiali di riciclo e sapiente manualità, un omaggio ininterrotto alla dignità della tradizione artigiana, come le lampade ultrapoverissime modellate da fogli di latta bucherellata e cucita senza saldature. L’insieme di queste opere racconta la sua personale interpretazione di un design della decrescita, i cui principi innervano tanto la fase progettuale – all’insegna di solidarietà, inclusione, sostenibilità – quanto quella realizzativa, privilegiando sobrietà e procedimenti virtuosi senza “assecondare né l’ ‘usa e getta’ né il rapido consumo, bensì il reimpiego e la durata”[1], e senza timore di interpellare la tecnologia e sperimentare. A tal proposito, proprio nel tentativo di incoraggiare una ricerca alternativa in questo campo, nel 2009 Dalisi ha presentato la prima edizione del Premio Compasso di latta, in collaborazione con la Triennale di Milano e la Naba – Nuova Accademia di Belle Arti.
Nella stessa prospettiva olistica ricade la sua visione di un’ “architettura della nuova innocenza”, in cui si saldano ai temi sociali quelli ambientali con particolare riferimento allo sperpero di risorse preziose. Egli auspica infatti “Una architettura aurorale che utilizzi il minimo e ciò che ci è vicino, sulla linea della ‘decrescita’: sprechi minimi o nulli.”[2]. Così, le carte dipinte e i plastici esposti in occasione delle sue mostre veicolano il senso di un’architettura liberata, che ai consueti principi di efficienza e sicurezza antepone le urgenze di una rinnovata convivialità e di una relazione privilegiata con la natura. L’esigenza non è solo intellettuale, ma intimamente spirituale. Il desiderio di conseguire una nuova salda relazione tra natura e architettura, infatti, tema dominante della fase più matura della sua poetica, esige una “nuova visione dell’essere nel mondo” che trae ispirazione tanto da Friedensreich Hundertwasser (precursore della bioarchitettura) quanto da Raimon Panikkar e Serge Latouche. I disegni di questo periodo deflagrano in prospettive ripidissime, intrecci dinamici di linee e di rami, di foglie e scale e finestre proiettati verso il cielo in slanci gioiosi sorretti da un cromatismo brillante. Prive di apprensioni costruttive, le tavole recenti sono piuttosto odi ad un progettare visionario, frutto di un’immaginazione senza confini, che ci consegna tracce, desideri, interrogativi, spunti da elaborare. La rilevanza del potere immaginativo, della creatività libera, manuale, partecipata, sostenuta da Dalisi appartiene già, insieme ad una istintiva propensione ai valori proto-decrescenti, alla prima fase della sua attività, avviatasi nel clima inquieto e contestatario della fine degli anni Sessanta.
Tra i firmatari del manifesto per l’Architettura Radicale (1968), Dalisi teorizza e conduce tra il 1971 e il 1974 quella iniziativa geniale – anticipatrice della Global Tools[3] – che sono i laboratori di strada con i bambini del sottoproletariato napoletano, confinati nella complessa realtà del Rione Traiano[4]. In questi coinvolge anche gli studenti della Facoltà di Architettura affinché evadano dall’ambiente asfittico dell’università, tutta chiusa nel binomio produzione-consumo, e si espongano a stimoli di segno diverso per rigenerare l’immaginazione creativa. I laboratori nascono, infatti, sia come reazione fattiva all’impasse dell’architettura, irrisolvibile nel mero teorizzare, sia come risposta alla crisi sociale. L’architettura diviene così strumento di partecipazione il cui potenziale come mezzo efficace e multiforme di lotta è vincolato all’ “azione diretta” in luoghi il più possibile “puri”, scevri cioè dalle sovrastrutture intellettualistiche imposte dalla società dei consumi, ove cominciava tra l’altro ad affermarsi il predominio di una tecnica sofisticata e specialistica con risultati alienanti[5]. L’azione contro l’emarginazione sociale non è quindi distinta ma integrata alla critica della condizione professionale nel contesto produttivistico. Si procede perciò su più piani contemporaneamente, il progettuale e il sociale, il metodologico e il politico.
Dalle particolari caratteristiche di questo progetto scaturisce la cosiddetta tecnica “radicale” o “povera”, o ancora meglio “tecnica di partecipazione”[6], una vera e propria visione del mondo che sollecita l’individuo a concorrere alla costruzione del proprio spazio e quindi del proprio universo, senza delegare. Tale tecnica non impiega attrezzature costose, ma neanche presuppone l’uso di rifiuti – spiega Riccardo Dalisi – piuttosto di materiali basilari, semplici; e neppure necessita di conoscenze da manuale, al contrario richiede una metodologia spontanea; non mira a codificare un’edilizia della miseria, ma innestandosi su una pratica d’animazione fa da detonatore per la trasformazione sociale; infine, non è “un revival dell’artigianato ma ne fa rinascere il senso ed il significato politico (…)”[7]. La valorizzazione della manualità e dell’artigianato non vanno letti però in chiave anti-industriale, piuttosto servono lo scopo di una ridefinizione sperimentale e rivitalizzante della relazione uomo-tecnica e quindi della produzione non consumistica.
In questi laboratori didattici per l’ideazione e l’assemblaggio di oggetti, bambini tra i dieci e i quindici anni esercitano una sorta di lavoro ludico realizzando giocattoli, piccoli mobili e strutture in legno, oggetti di cartapesta, manufatti in ferro, mentre si configura attorno a loro un progetto di enorme respiro che di per se stesso è processo. Qui si intersecano realtà socio-culturali distanti atte ad un’indagine di stampo pedagogico e sociopsicologico”[8] da cui scaturiscono sottili osservazioni su temi chiave, ad esempio il valore sociale del lavoro o la funzione dello sviluppo tecnologico[9].
Si capirà da ciò quanto sfaccettato e anticonvenzionale sia il pensiero di Dalisi cui contribuiscono, oltre alla maieutica di Danilo Dolci, la Pedagogia degli oppressi di Paulo Freire e la teorica del dono di Marcel Mauss e Jacques Godbout che sarà importante anche negli anni duemila[10]. Stimolante in questo contesto è il parallelo con Ivan Illich, in relazione al quale più che di influenza si dovrebbe parlare di convergenza di vedute. I presupposti, le modalità di costruzione e le finalità dei laboratori, esperienza incernierata su partecipazione[11], impiego di materiali basilari e tecnologie gestibili da chiunque, sembrano infatti rispecchiare il senso dello strumento conviviale[12] concepito da Illich, le cui idee circolavano veloci nella cerchia dei radical, in particolare dopo la pubblicazione di Deschooling Society[13]. E non è tutto. L’architetto condivide con Illich anche l’atteggiamento critico verso la professionalizzazione, nonché la già annoverata esaltazione di una creatività individuale aperta al disordine, al caos fecondo, alla casualità, al non programmato, possibilmente libera dalle rigidità di “(…) metodi illuministici distaccati ed univocamente razionali”[14]. Si consideri infine anche quanto, a differenza di altri colleghi, Dalisi insistesse sulla riappropriazione del valore d’uso piuttosto che sulla rilevanza del valore di scambio propugnata invece dall’operaismo[15], cosa che implicò una certa divaricazione dalle posizioni più strettamente marxiste preminenti nella Global Tools – in ciò ravvisiamo ancora una volta una prossimità all’intellettuale austriaco.
Insomma, tra la tecnica povera e il design della Decrescita corre una linea continua e coerente. Appurata la sintonia teorica e spirituale, c’è da chiedersi quanto, cosa (e come) si possa trarre dall’affascinante lascito di Dalisi per operare l’urgente conversione dell’immaginario collettivo, da egli stesso auspicata, per de-mercantizzare e superare il consumo compulsivo. Tutti obiettivi che egli riteneva perseguibili anche passando attraverso la codificazione di un design e di una architettura rinnovati dall’apporto della decrescita.
[1] Riccardo Dalisi, Decrescita. Architettura della Nuova Innocenza, Corraini Editore, Mantova, 2009, p. 100
[2] Ibid. p. 155
[3] Esperienza laboratoriale multidisciplinare la “Global Tools” fu ideata e animata tra il 1973 e il 1975 dagli esponenti dell’architettura e del design radicale Archizoom Associati, Remo Buti, Casabella, Riccardo Dalisi, Ugo La Pietra, 9999, Gaetano Pesce, Gianni Pettena, Rassegna, Ettore Sottsass Jr, Superstudio, Ufo e Zziggurat. Vi aderirono anche alcuni artisti come Franco Vaccari, Giuseppe Chiari e Luciano Fabro introdotti dal critico d’arte Germano Celant. Cfr. Global Tools Documento 1, in “Casabella” n.377, gennaio 1973; Valerio Borgonuovo e Silvia Franceschini (a cura di), Global Tools 1973-1975, SALT/Garanti Kültur As, Istanbul, 2015.
[4] Costruito a partire dal 1957, il Rione Traiano si presentava sulla carta come ambizioso piano di edilizia residenziale pubblica sul modello scandinavo. Rimase tuttavia incompiuto, senza che fossero realizzati i servizi inizialmente previsti come strade, scuole, uffici, negozi, aree verdi, e finì con l’ospitare oltre il 50% in più della popolazione attesa, sprofondando nell’isolamento e nel degrado.
[5] Con lucida consapevolezza, Dalisi sosteneva la revisione delle modalità di produzione, tra tecnologia e manualità artigiana, qualcosa che ha cercato di tradurre nella sua interpretazione dell’architettura e del design, lavoro arduo visto quanto quest’ultimo sia legato agli sviluppi dell’economia industriale. Cfr. Riccardo Dalisi con la partecipazione di Filippo Alison e Dino Rossi, Tecnica Povera. La funzione del pressappoco nell’universo della precisione, in “Casabella” n.386, febbraio 1974, pp. 43–45.
[6] Riccardo Dalisi, La tecnica povera in rivolta: La cultura del sottoproletariato, in “Casabella” n.365, maggio 1972, pp. 28–34.
[7] Ibidem.
[8] Riccardo Dalisi, “Tecnica povera e produttività disperata”, Casabella n. 382, ottobre 1973, pp. 46–47.
[9] Un intervento denso e intenso a tal proposito è rintracciabile in Riccardo Dalisi con la partecipazione di Filippo Alison e Dino Rossi, Op.cit., 1974, pp. 43–45.
[10] Cfr. “Un design del dono”, in Decrescita. Architettura della nuova innocenza, op.cit., pp. 108.
[11] Si veda Riccardo Dalisi, La partecipazione creativa è possibile, in “Casabella”, 368-369, settembre-ottobre 1972, pp. 96-97.
[12] Cfr. Ivan Illich, La convivialità (1973), Mondadori, Milano, 1974. Introduzione: “Chiamo società conviviale una società in cui lo strumento moderno sia utilizzabile dalla persona integrata con la collettività, e non riservato a un corpo di specialisti che lo tiene sotto il proprio controllo. Conviviale è la società in cui prevale la possibilità per ciascuno di usare lo strumento per realizzare le proprie intenzioni. Parlando di ‘convivialità’ dello strumento mi rendo conto di dare un senso in parte nuovo al significato corrente della parola. Lo faccio perché ho bisogno di un termine tecnico per indicare lo strumento che sia scientificamente razionale e destinato all’uomo austeramente anarchico.”
[13] Il saggio fu pubblicato da Harper & Row, New York, nel 1971. Ricordiamo inoltre, che le sollecitazioni teoriche in quella fase storica erano molteplici, si veda ad esempio il Victor J. Papanek di Design for the Real World: Human Ecology and Social Change, 1971 e il Claude Levi-Strauss di La pensée sauvage, 1962.
[14] Alessandro Mendini, “Dalisi e l’imprevedibilità”. In R. Dalisi (1975). Architettura d’animazione, cultura del proletariato e lavoro di quartiere a Napoli (pp. 3-14). Carucci Editore. 1975, pp. 13-14.
[15] Si veda Sara Catenacci e Jacopo Galimberti, “Deschooling, Manual Labour, and Emancipation: The Architecture and Design of Global Tools, 1973-1975”, pp. 99- 121, in Meredith A. Brown e Michelle Millar Fisher (ed.), Collaboration and its (Dis)Contents: Art, Architecture, and Photography since 1950, 2017, The Courtauld Institute of Art, Londra, p. 112; cfr. anche Riccardo Dalisi, ‘L’appropriazione contro la progettazione’, In 13 (Autunno 1974), pp. 11–12.
Immagini: Courtesy Archivio Riccardo Dalisi e Museo MAXXI